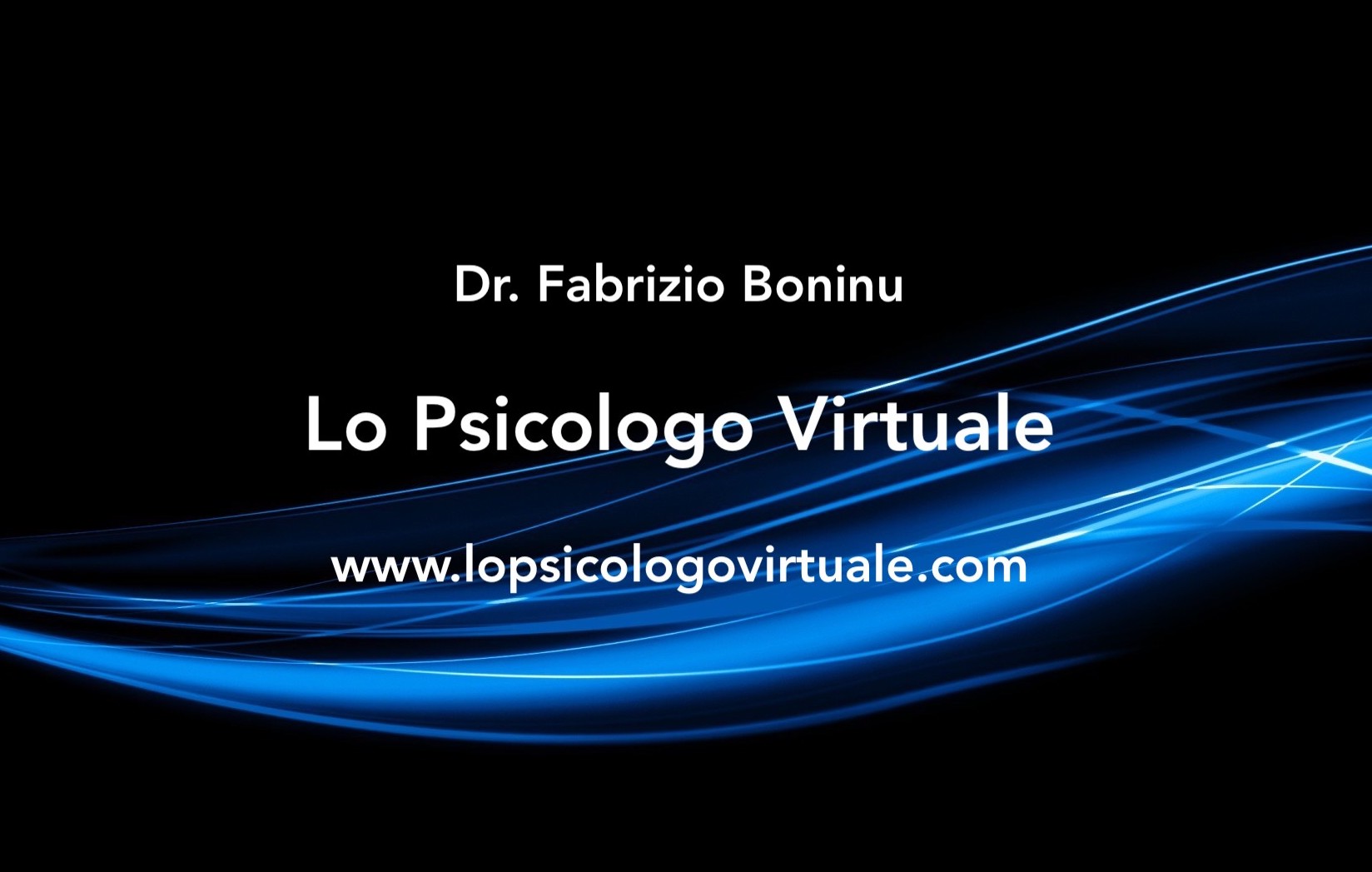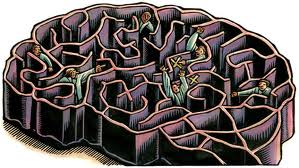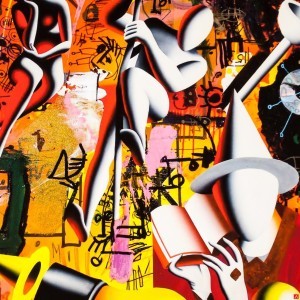Ricevo, qualche mese fa, un commento ad un mio articolo riguardante i terapeuti riparatori. In questo post sostenevo la pericolosità, per l’intera categoria professionale, dei colleghi che, reputandosi depositari di una verità da imporre agli altri, si trovano a voler cambiare e a voler guarire aspetti della personalità che da tempo sono stati derubricati nella comunità scientifica dalle categorie di patologie mentali. (Il post è stato pubblicato il 14.07.2013. Clicca Il terapeuta riparatore per leggere l’articolo). Nel commento mi si accusa di “nascondere e sottrarre risposte”, perciò ho pensato che la pubblicazione integrale, ed una integrazione, dello scambio non possa che fugare i possibili dubbi di qualsivoglia censura operata da parte mia.
Ricevo, qualche mese fa, un commento ad un mio articolo riguardante i terapeuti riparatori. In questo post sostenevo la pericolosità, per l’intera categoria professionale, dei colleghi che, reputandosi depositari di una verità da imporre agli altri, si trovano a voler cambiare e a voler guarire aspetti della personalità che da tempo sono stati derubricati nella comunità scientifica dalle categorie di patologie mentali. (Il post è stato pubblicato il 14.07.2013. Clicca Il terapeuta riparatore per leggere l’articolo). Nel commento mi si accusa di “nascondere e sottrarre risposte”, perciò ho pensato che la pubblicazione integrale, ed una integrazione, dello scambio non possa che fugare i possibili dubbi di qualsivoglia censura operata da parte mia.
Questo il commento: Repubblica quest’anno ha pubblicato una lettera di un ragazzo “omosessuale” che “riteneva la sua condizione una sfortuna e diceva di avere pensato al suicidio. E’ UNO SCANDALO che a questi ragazzi non venga detta la verità e cioè che Jung e Adler, i pilastri della psicananalisi curavano l’omosessualità. Quanto agli psicanalisti che l’hanno curata e la curano dal 1950 al 2014, e che hanno scritto abbondantemente su questo, un piccolo elenco – MOLTO parziale – è il seguente: EDMUND BERGLER, ELIZABETH MOBERLY, CHARLES SOCARIDES( HOMOSEXUALITY A FREEDOM TOO FAR, IRVING BIEBER( HOMOSEXUALITY A PSYCHOANALITIC STUDY), BENJAMINK KOFFMAN , JANELLE HALLMAN, DEAN BYRD, RICHARD COHEN ( COMING OUT SRAGHT), JOE DALLAS, BOBBY MORGAN, STANTON JONES, JEFFREY SATINOVER, JOSEPH NICOLOSI (SHAME AND ATTACHMENT LOSS), JOHN LAWRENCE HATTERER( CHANGING HOMOSEXUALITY IN THE MALE),ETC…
SPERO CHE PRIMA O POI QUALCUNO CHIEDA GIUSTIZIA DELL’OCEANO DI CONOSCENZE E INFORMAZIONI CHE GLI PSICOLOGI – COME LEI – HANNO SISTEMATICAMENTE NASCOSTO E SOTTRATTO AI RAGAZZI IN CERCA DI RISPOSTA.
Questa la mia risposta: Salve Federico, benvenuto. Guardi l’unico scandalo di questa sua mail è la scortesia del tono che usa. E’ a conoscenza del fatto che scrivere tutto in maiuscolo equivale ad urlare? E ancora sostiene che io nasconda informazioni. Le sembra che se volessi nascondere informazioni creerei un blog pubblico? O pubblicherei il suo commento? Ma veniamo a noi. Capisco la spinosità dell’argomento, e sono a conoscenza del fatto che molti miei (ben più illustri) colleghi hanno sostenuto la curabilità dell’omosessualità (con risultati che definire discutibili è un puro eufemismo). Non conosco le loro motivazioni, anche se per molti di loro giocò un ruolo rilevante la fede o l’età. Elizabeth Moberly era teologa per esempio. Parliamo di come una realtà personale venga traslata su questioni sociali. Ben altro numero di colleghi ha di fatto smentito una volta per tutte questo delirio patologizzante, depennando definitivamente l’omosessualità nel 1973 (41 anni fa) quando l’American Psychiatric Association rimosse l’omosessualità dal DSM (il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), negando così la sua precedente definizione di omosessualità come disordine mentale (fonte Wikipedia).
Tutto il resto sono illazioni non più approvate dalla comunità scientifica. Lei è naturalmente libero di credere ciò che vuole, ma la differenza tra me e lei è che io non voglio imporre le mie risposte su quella che è la vita di un’altra persona per cui l’unica cosa che mi sento di fare è provare un profondo rispetto. E stia pur certo che nessuna mia risposta influenzerà le scelte delle persone che ho la fortuna di incontrare nel mio lavoro. Grazie per l’intervento!
Potremmo aggiungere un riferimento particolare su Joseph Nicolosi, uno dei massimi esponenti delle cosiddette terapie riparative. Nicolosi, psicologo statunitense, è noto essenzialmente per le sue teorie riparative sull’omosessualità. Nicolosi ha espresso la strategia nella sua interezza, ne ha indicato scopi, metodi ed esiti, rispetto ai quali è molto più lucido dei suoi seguaci, preferendo al termine ‘guarigione’ quello più ambiguo e confusivo di ‘cambiamento’. Le sue posizioni sono inequivocabili, al contrario di quelle dei nuovi terapeuti fautori della ‘terapia dell’identità sessuale’, che sembrano prendere le distanze da lui, apparendo meno drastici e netti, ma in realtà sostengono la promozione dell’eterosessismo sociale (e di conseguenza l’omonegatività che ne è corollario). Nicolosi basa il suo insegnamento sulla pretesa di essere ‘scientifico’, laico persino, sottacendo le premesse fondamentaliste, da lui poste come un dato di fatto indiscutibile. Da lui tutti i vari movimenti, religiosi e no, hanno preso ispirazione e alimento. [1]
Il guaio delle teorie riparatorie è che, avendo come premessa il fatto di sapere cosa sia o non sia giusto per l’altro, cercano di imporre una soluzione, una ‘cura’ per l’appunto su quello che è il sentire dell’altro. Non avendo alcuna verità in tasca, penso semplicemente di poter cercare di comprendere, più che cambiare o guarire, la persona che mi si siede davanti ed, in generale, le persone che incontro. Diffido di coloro che pensano di poter guarire o modificare l’altro perché non condivido nulla della loro premessa epistemologica: io so cosa è giusto fare per te. Se pensate che debba fare questo non rivolgetevi a me perché, semplicemente, non sono in grado di (e non voglio!) farlo! E spero che questo post chiarisca una volta di più come la censura non mi appartenga, per quanto le idee o le posizioni di cui si parla siano agli antipodi dal mio modo di pensare.
Che ne pensate?
A presto…
[1]Rigliano, P., Ciliberto, J., Ferrari, F. (2012), Curare i gay?, Raffaello Cortina Editore, Milano, pag. 15
Tutti i diritti riservati