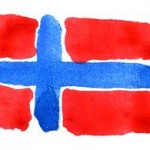Il post di oggi riguarda un argomento che è sotto gli occhi di tutti ma del quale spesso fingiamo di non accorgerci e di non notare. Il tema è un argomento scabroso dal momento che riguarda le differenze di sviluppo tra bambini a seconda della classe di reddito a cui appartiene. La riflessione è scaturita dalla lettura di un passo del testo Il vaso di Pandora. [1] La tesi che si sostiene è che il bambino cresca per imitazione del modello che viene proposto dagli adulti per lui importanti in quella prima fase di vita. Questo rapporto avrebbe conseguenze sul successivo sviluppo del bimbo e anche sullo sviluppo di alcune patologie. Secondo gli studi di Hollingshead e di Redlich si riscontrerebbe un’alta incidenza di disturbi di tipo nevrotico nelle classi sociali più alte, un’alta incidenza di disturbi psicopatici nelle classi sociali più deboli. Ovviamente, trattandosi di una tesi per il quale lo sviluppo del bambino avviene fondamentalmente per imitazione, il modello che viene fornito al bambino può essere diverso a seconda di quelli che sono i mezzi e gli strumenti che hanno gli adulti stessi. E se si dovesse far un raffronto con le differenze tra bambini di classi sociali diverse, potremmo notare come queste siano dovute alle competenze degli adulti significativi. Come abbiamo visto, alcuni studi dimostrano infatti come i disturbi psichiatrici siano distribuiti diversamente a seconda della classe sociale. Questa diversa distribuzione avrebbe delle influenze anche linguistiche e sulla costruzione del sé del bambino. I bambini che che vivono in un ambiente proletario o sottoproletario apprendono dai loro genitori e utilizzano nella loro interazione un codice (linguistico) ‘ristretto’, povero di riferimenti alle emozioni vissute e di tendenza alla simbolizzazione. In termini interattivi ciò corrisponde evidentemente allo sviluppo di una patologia di tipo piuttosto comportamentale che nevrotico. Il contrario accade, evidentemente, per bambini che vengono addestrati ad utilizzare un codice ‘elaborato’: soprattutto se vivono all’interno di famiglie in cui l’uso ampio e consensuale di meccanismi di difesa basati sulla rimozione (…)li spinge alla ricerca di formulazioni allusive e di elaborazioni simboliche del loro vissuto. Cosa vuol dire questo? Sostanzialmente si tratta di verificare come nelle classi sociali più alte ci sarebbe una diversa sensibilità all’utilizzo di un linguaggio che possa aiutare a definire i propri stati emozionale. Questo permetterebbe al bambino di apprendere a riferirsi a queste realtà emozionali in termini simbolici e di poterle astrarre. Per questo motivo, tale capacità appresa potrebbe essere alla base, nel caso di sviluppo di patologie, ad un decorso nevrotico piuttosto che psicotico o comportamentale, che sarebbe invece la ‘strada patologica’ di bambini che non sono stati abituati a fare questo da adulti che, probabilmente, non avevano le risorse necessarie per farlo neanche con se stessi. Questi studi sono di matrice americana, e descrivono una realtà sociale per certi versi diversa dalla nostra. Credo che questa riflessione fosse interessante se prendiamo in considerazione il fatto che non esiste un modello puro ma che stiamo parlando di tendenze utili per la descrizione. Se è vero che le classi possono fare la differenza sullo sviluppo, è anche vero che oggi viviamo circondati da tutta una serie di stimoli che potrebbe attenuare queste tendenze.
Il post di oggi riguarda un argomento che è sotto gli occhi di tutti ma del quale spesso fingiamo di non accorgerci e di non notare. Il tema è un argomento scabroso dal momento che riguarda le differenze di sviluppo tra bambini a seconda della classe di reddito a cui appartiene. La riflessione è scaturita dalla lettura di un passo del testo Il vaso di Pandora. [1] La tesi che si sostiene è che il bambino cresca per imitazione del modello che viene proposto dagli adulti per lui importanti in quella prima fase di vita. Questo rapporto avrebbe conseguenze sul successivo sviluppo del bimbo e anche sullo sviluppo di alcune patologie. Secondo gli studi di Hollingshead e di Redlich si riscontrerebbe un’alta incidenza di disturbi di tipo nevrotico nelle classi sociali più alte, un’alta incidenza di disturbi psicopatici nelle classi sociali più deboli. Ovviamente, trattandosi di una tesi per il quale lo sviluppo del bambino avviene fondamentalmente per imitazione, il modello che viene fornito al bambino può essere diverso a seconda di quelli che sono i mezzi e gli strumenti che hanno gli adulti stessi. E se si dovesse far un raffronto con le differenze tra bambini di classi sociali diverse, potremmo notare come queste siano dovute alle competenze degli adulti significativi. Come abbiamo visto, alcuni studi dimostrano infatti come i disturbi psichiatrici siano distribuiti diversamente a seconda della classe sociale. Questa diversa distribuzione avrebbe delle influenze anche linguistiche e sulla costruzione del sé del bambino. I bambini che che vivono in un ambiente proletario o sottoproletario apprendono dai loro genitori e utilizzano nella loro interazione un codice (linguistico) ‘ristretto’, povero di riferimenti alle emozioni vissute e di tendenza alla simbolizzazione. In termini interattivi ciò corrisponde evidentemente allo sviluppo di una patologia di tipo piuttosto comportamentale che nevrotico. Il contrario accade, evidentemente, per bambini che vengono addestrati ad utilizzare un codice ‘elaborato’: soprattutto se vivono all’interno di famiglie in cui l’uso ampio e consensuale di meccanismi di difesa basati sulla rimozione (…)li spinge alla ricerca di formulazioni allusive e di elaborazioni simboliche del loro vissuto. Cosa vuol dire questo? Sostanzialmente si tratta di verificare come nelle classi sociali più alte ci sarebbe una diversa sensibilità all’utilizzo di un linguaggio che possa aiutare a definire i propri stati emozionale. Questo permetterebbe al bambino di apprendere a riferirsi a queste realtà emozionali in termini simbolici e di poterle astrarre. Per questo motivo, tale capacità appresa potrebbe essere alla base, nel caso di sviluppo di patologie, ad un decorso nevrotico piuttosto che psicotico o comportamentale, che sarebbe invece la ‘strada patologica’ di bambini che non sono stati abituati a fare questo da adulti che, probabilmente, non avevano le risorse necessarie per farlo neanche con se stessi. Questi studi sono di matrice americana, e descrivono una realtà sociale per certi versi diversa dalla nostra. Credo che questa riflessione fosse interessante se prendiamo in considerazione il fatto che non esiste un modello puro ma che stiamo parlando di tendenze utili per la descrizione. Se è vero che le classi possono fare la differenza sullo sviluppo, è anche vero che oggi viviamo circondati da tutta una serie di stimoli che potrebbe attenuare queste tendenze.
Voi che ne pensate?
A presto…
Fabrizio
[1] Cancrini, L., La Rosa, C. (1991), Il vaso di Pandora, Carocci, Roma, pag. 163
Tutti i diritti riservati