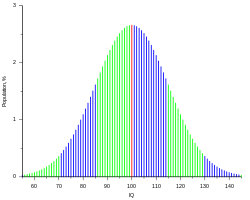Il post di oggi vuole occuparsi di un tema del quale mi era già occupato in passato (L’idealizzazione dello psicologo, 06.12.2011) e che riguarda un aspetto molto importante all’interno della terapia. Sto parlando dell’ idealizzazione dello psicologo, quel processo mediante il quale il terapeuta viene appunto idealizzato da un suo paziente e che porta il paziente ad identificare il suo medico come una sorta di guru che tutto può e che tutto risolve. Ora questa posizione, lungi dall’essere una posizione facilmente gestibile all’interno di un percorso psicoterapeutico per il paziente, è pericolosa per lo stesso terapeuta che può trovare solleticate in terapie parti di sé onnipotenti che, se non conosciute e risolte, possono sfociare nel riconoscimento e nell’accettazione di questo ruolo.
Il post di oggi vuole occuparsi di un tema del quale mi era già occupato in passato (L’idealizzazione dello psicologo, 06.12.2011) e che riguarda un aspetto molto importante all’interno della terapia. Sto parlando dell’ idealizzazione dello psicologo, quel processo mediante il quale il terapeuta viene appunto idealizzato da un suo paziente e che porta il paziente ad identificare il suo medico come una sorta di guru che tutto può e che tutto risolve. Ora questa posizione, lungi dall’essere una posizione facilmente gestibile all’interno di un percorso psicoterapeutico per il paziente, è pericolosa per lo stesso terapeuta che può trovare solleticate in terapie parti di sé onnipotenti che, se non conosciute e risolte, possono sfociare nel riconoscimento e nell’accettazione di questo ruolo.
Questo porta la terapia ad essere potenzialmente rischiosa per il paziente stesso e la presa in carico terapeutica si rivela estremamente difficile da gestire. Di questo tema si sono occupati tutti i più grandi terapeuti sistemico familiari. Vi riporto la posizione in proposito di uno dei più grandi e originali innovatori in materia, Carl Whitaker nel suoConsiderazioni notturne di un terapeuta della famiglia:
Una delle difficoltà di accedere al campo di gioco terapeutico dipende dal delirio di grandezza che viene sollecitato dal paziente e dei suoi bisogni; il terapeuta è visto come un Dio onnipotente e onnisciente. Mi pare inoltre chiaro che, come il terapeuta è al centro del mondo del paziente, il paziente e al centro del mondo del terapeuta. Se il terapeuta si fa sedurre da questo delirio di grandezza, la terapia diventa inutile. [1]
Il rischio è appunto questo: se il terapeuta si fa sedurre da questo delirio di grandezza, la terapia diventa inutile. Vi starete chiedendo forse se un terapeuta non dovrebbe essere pronto a gestire investimenti di questo tipo da parte di un suo paziente. Dovrebbe. Ma non sempre è facile gestire questo tipo di dinamiche. Soprattutto nel momento in cui possono essere così pervasive o seducenti da indurre il terapeuta stesso a crederci. La difficoltà più grande può essere quella per cui, una volta attivato e non riconosciuto questo meccanismo da parte del terapeuta stesso, questo si propaghi e si espanda vanificando di fatto la terapia.
Se il terapeuta crede infatti al ruolo ‘divino’ che il paziente gli (o le naturalmente!) assegna, si comporterà come tale e, invece di far riflettere il suo stesso paziente sulla sua vita, gli subentrerà, dispensando consigli e modi su come lui affronterebbe una data situazione e sostituendosi de facto al paziente stesso. Questo confermerà l’idea in entrambi che uno dei due (il terapeuta) sia in una posizione superiore mentre l’altro (il paziente) sia in una posizione più bassa.
– Continua –
[1] Whithaker, C. (1989), Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia, Astrolabio, Roma, pag. 233
Tutti i diritti riservati