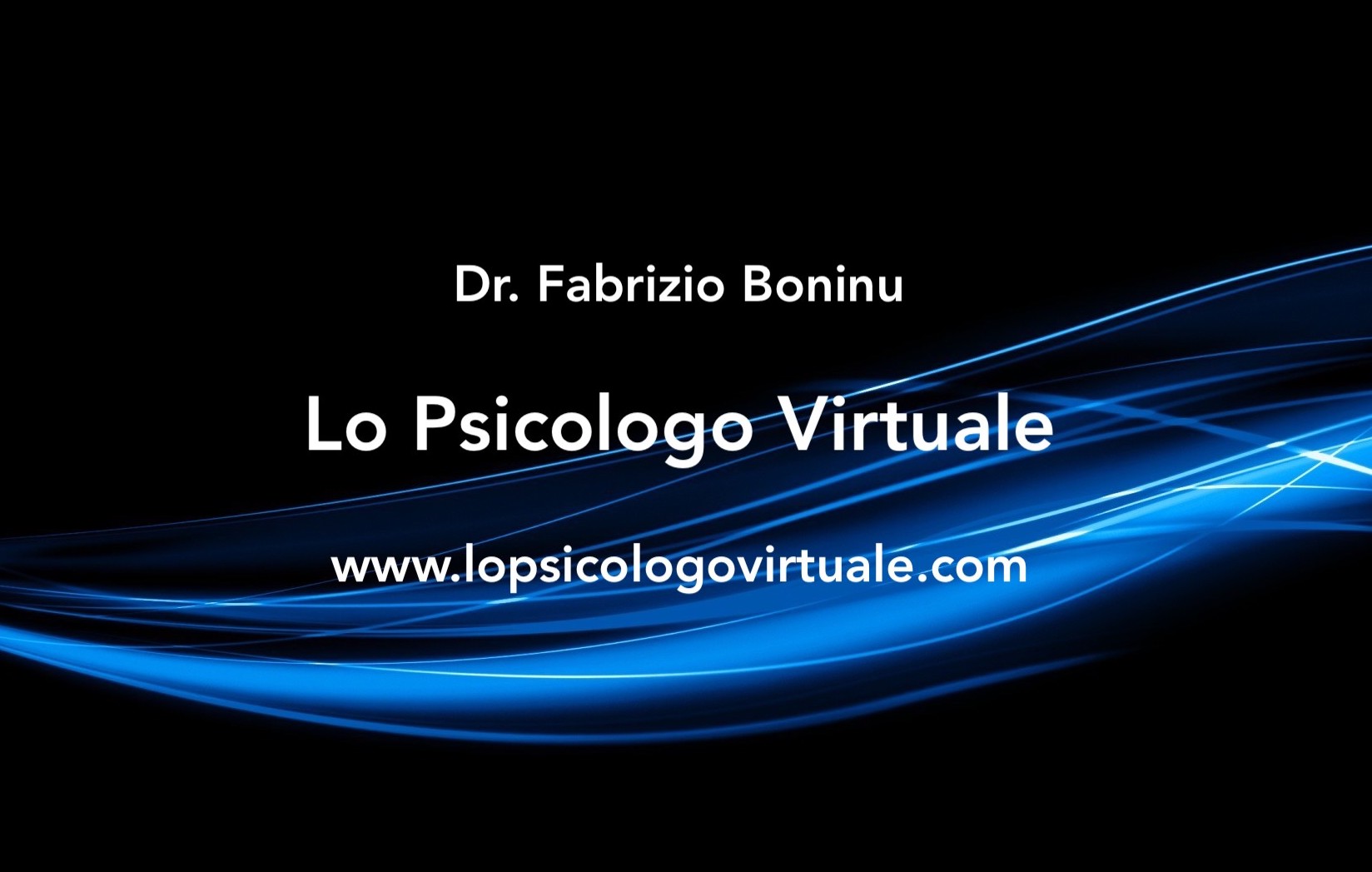Il post è una riflessione che parte dal bellissimo brano che Umberto Galimberti, filosofo e psicanalista italiano, scrisse all’indomani dell’ennesimo caso di cronaca nera che vedeva, nella parte dell’assassino, giovanissimi. La riflessione parte da questo punto: qual è il mondo interiore di questi giovani? Eccovi il pezzo:
Il post è una riflessione che parte dal bellissimo brano che Umberto Galimberti, filosofo e psicanalista italiano, scrisse all’indomani dell’ennesimo caso di cronaca nera che vedeva, nella parte dell’assassino, giovanissimi. La riflessione parte da questo punto: qual è il mondo interiore di questi giovani? Eccovi il pezzo:
L’hanno trovata morta in un cascinale abbandonato, vicino alla sua abitazione. Ancora non sanno se il ragazzo che ieri notte ha confessato il delitto ha agito da solo o insieme ad altri, che per ora restano in quella cupa ombra dove la sessualità si mescola alla violenza, in quel cocktail micidiale che, a dosi massicce, la televisione quotidianamente distribuisce nell’indifferenza generale.
Quel che è certo è che una brava ragazza di 14 anni, che sabato scorso era uscita con le chiavi di casa e il suo cellulare, come fanno tutti i ragazzi della sua età, a casa non tornerà più. Ma come è fatto il mondo fuori casa?Non dico il mondo in generale, ma il mondo di questi ragazzi di cui ieri, in un lucido intervento su Repubblica, Marco Lodoli ha descritto il loro apparato cognitivo in questi termini: “I processi intellettivi più semplici, un’elementare operazione matematica, la comprensione di una favoletta, ma anche il resoconto di un pomeriggio passato con gli amici o della trama di un film, sono diventati compiti sovrumani di fronte ai quali gli adolescenti rimangono a bocca aperta, in silenzio. (…)”. Semplicemente non capiscono niente, non riescono a connettere i dati più elementari, a stabilire dei nessi anche minimi tra i fatti che accadono davanti a loro, che accadono a loro stessi”.
A questa diagnosi (che posso tranquillamente confermare perché questi stessi ragazzi li ascolto quattro o cinque anni dopo, un po’ più evoluti ma non tanto, all’università) resta solo da aggiungere che carenti non sono solo i nessi “cognitivi”, verbalizzati con un linguaggio che più povero non si può immaginare, ma anche quelli “emotivi”, per cui viene da chiedersi se questi ragazzi dispongono ancora di una psiche capace di elaborare i conflitti e, grazie a questa elaborazione, in grado di trattenersi dal gesto. Esiste nella nostra attuale cultura e nelle nostre pratiche di vita un’educazione emotiva che consenta loro di mettere in contatto e quindi di conoscere i loro sentimenti, le loro passioni, la qualità della loro sessualità e i moti della loro aggressività? Oppure il mondo emotivo vive dentro di loro a loro insaputa, come un ospite sconosciuto a cui non sanno dare neppure un nome? Se così fosse, di fatti simili a questa tragedia avvenuta nel Bresciano aspettiamocene molti, perché è difficile pensare di poter governare la propria vita senza un’adeguata conoscenza di sé. E qui non alludo alla conoscenza postuma che in età adolescenziale o in età adulta porta qualcuno dallo psicoterapeuta a cercare l’anima o direttamente in farmacia nel tentativo di sedarla; ma faccio riferimento a quell’educazione dei sentimenti, delle emozioni, degli entusiasmi, delle paure, che mette al riparo da quell’indifferenza emotiva, oggi sempre più diffusa, per effetto della quale non si ha risonanza emozionale di fronte ai fatti a cui si assiste o ai gesti che si compiono. E chi non sa sillabare l’alfabeto emotivo, chi ha lasciato disseccare le radici del cuore, si muove nel mondo pervaso da un timore inaffidabile e quindi con una vigilanza aggressiva spesso non disgiunta da spunti paranoici che inducono a percepire il prossimo innanzitutto come un potenziale nemico.
E tutto ciò perché? Perché manca un’educazione emotiva: dapprima in famiglia, dove i giovanissimi trascorrono il loro tempo in quella tranquilla solitudine con le chiavi di casa in tasca e la televisione come baby sitter, e poi a scuola, quando ascoltano parole che fanno riferimento a una cultura che, per esser tale, non può che esser distante mille miglia da ciò che la televisione ha loro offerto come base di reazione emozionale. Oggi l’educazione emotiva è lasciata al caso e tutti gli studi e le statistiche concordano nel segnalare la tendenza, nell’attuale generazione, ad avere un maggior numero di problemi emozionali rispetto a quelle precedenti. E questo perché oggi i giovanissimi sono più soli e più depressi, più rabbiosi e ribelli, più nervosi e impulsivi, più aggressivi e quindi impreparati alla vita, perché privi di quegli strumenti emotivi indispensabili per dare avvio a quei comportamenti quali l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, l’empatia, senza i quali saranno sì capaci di parlare, ma non di ascoltare, di risolvere i conflitti, di cooperare. Se la scuola non è sempre all’altezza dell’educazione emotiva, che prevede, oltre a una maturazione intellettuale, anche una maturazione psicologica, l’ultima chance potrebbe offrirla la società se i suoi valori non fossero solo business, successo, denaro, immagine, ma anche qualche straccio di solidarietà, relazione, comunicazione, aiuto reciproco, che possano temperare il carattere asociale che, nella nostra cultura, caratterizza sempre di più il mondo giovanile. Nel deserto della comunicazione emotiva che da piccoli non è loro arrivata, da adolescenti non hanno incontrato, e nelle prossimità dell’età adulta hanno imparato a controllare, fa la sua comparsa il “gesto”, soprattutto quello violento, che prende il posto di tutte le parole che questi ragazzi non hanno scambiato né con gli altri per istintiva diffidenza, né con se stessi per afasia emotiva.
Si tratta di gesti che mettono in crisi la giustizia e, con la giustizia, la società che per tranquillizzarsi è sempre alla ricerca di un movente. E il movente in effetti non c’è, o se c’è è insufficiente, comunque sproporzionato alla tragedia, persino ignoto agli stessi autori. Cercarlo ci porta lontano, tanto lontano quanto può esserlo l’avvio della nostra vita, dove ci è stato insegnato tutto, ma non come “mettere in contatto” il cuore con la nostra mente, e la nostra mente con il nostro comportamento, e il comportamento con il riverbero emotivo che gli eventi del mondo incidono nel nostro cuore. Queste “connessioni”, che fanno di un uomo un uomo, non si sono costituite, e perciò sono nate biografie capaci di gesti tra loro a tal punto slegati, da non percepirli neppure come propri. Questo è il nostro tempo, il tempo che registra il fallimento della comunicazione emotiva e quindi la formazione del cuore come organo che prima di ragionare, ci fa “sentire” che cosa è giusto e che cosa non è giusto, chi sono io e che ci faccio al mondo.
UMBERTO GALIMBERTI, Gli analfabeti delle emozioni, La Repubblica, 5 ottobre 2002.
Che ne pensate?
A presto…
Tutti i diritti riservati