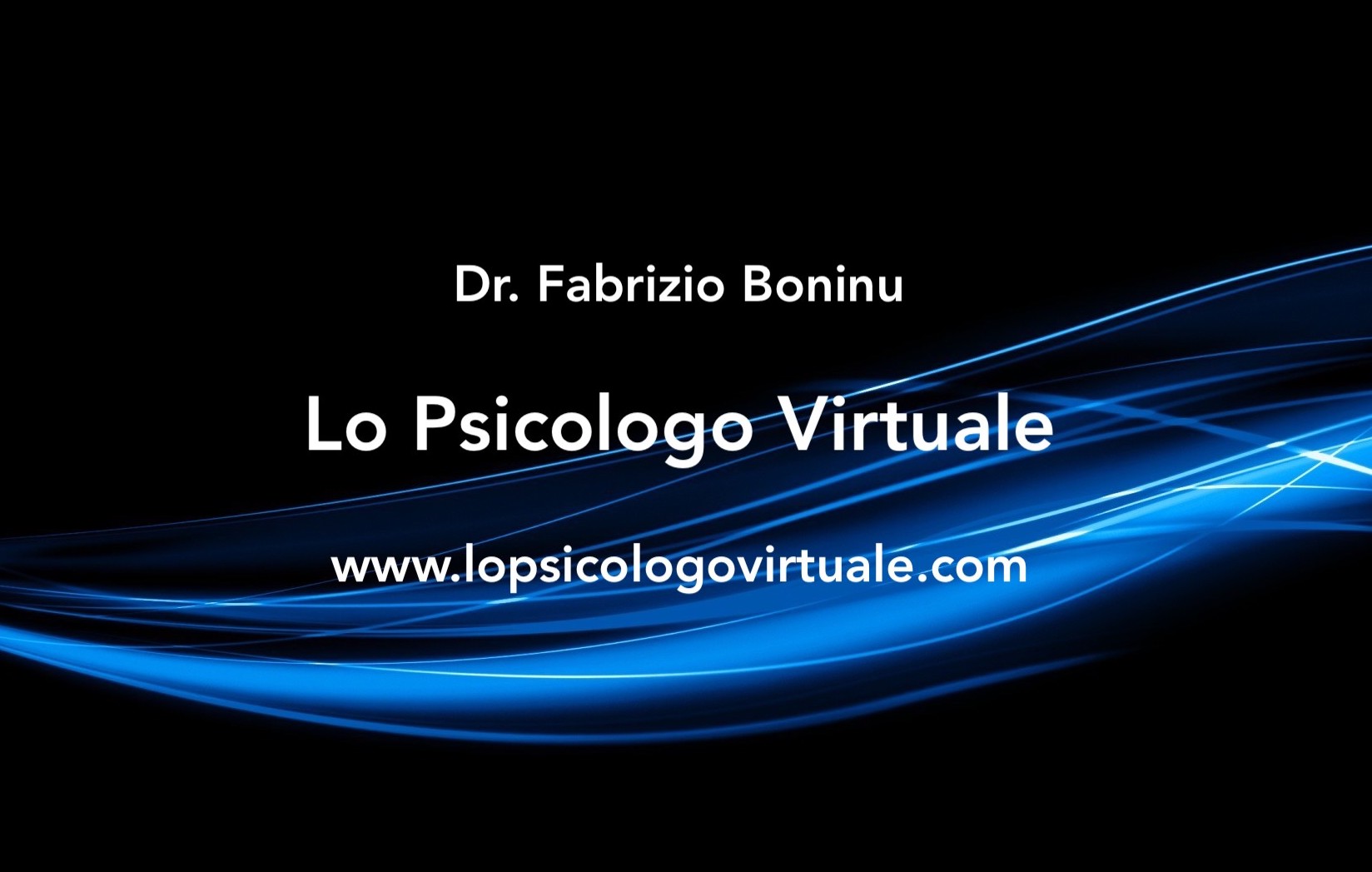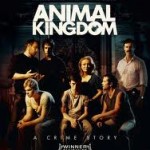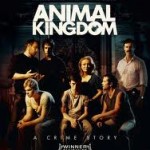 Il film che voglio raccontarvi oggi è un film che narra le vicende di una famiglia molto particolare. Si intitola Animal kingdome (2010) del regista David Michod. Il film racconta la storia di Joshua, detto “J” Cody. Il ragazzo, diciassettenne, perde la madre per un overdose e chiama la nonna materna ad occuparsi della situazione. La nonna lo porta in casa sua dove vive con gli altri tre suoi figli, zii di Joshua. L’unico particolare che vi aggiungo è che la famiglia sembra dedita alla criminalità per vivere e sembrano molto ambigui i rapporti tra i membri della famiglia stessa. La famiglia è organizzata all’interno di una confusione e di una ambiguità che colpiscono. Gli zii sembrano, infatti, sebbene tutti e tre adulti, ancora molto figli della signora e sembrano essere tutti in un rapporto di parità tra loro. Anche il rapporto tra la madre e figli sembra essere particolare, morboso. Per buona parte del film non viene spiegato dove sia il padre.
Il film che voglio raccontarvi oggi è un film che narra le vicende di una famiglia molto particolare. Si intitola Animal kingdome (2010) del regista David Michod. Il film racconta la storia di Joshua, detto “J” Cody. Il ragazzo, diciassettenne, perde la madre per un overdose e chiama la nonna materna ad occuparsi della situazione. La nonna lo porta in casa sua dove vive con gli altri tre suoi figli, zii di Joshua. L’unico particolare che vi aggiungo è che la famiglia sembra dedita alla criminalità per vivere e sembrano molto ambigui i rapporti tra i membri della famiglia stessa. La famiglia è organizzata all’interno di una confusione e di una ambiguità che colpiscono. Gli zii sembrano, infatti, sebbene tutti e tre adulti, ancora molto figli della signora e sembrano essere tutti in un rapporto di parità tra loro. Anche il rapporto tra la madre e figli sembra essere particolare, morboso. Per buona parte del film non viene spiegato dove sia il padre.
Vi riporto questo film perché credo possa rappresentare molto bene, ovviamente con un esito, quello criminale, che non sempre è scontato in situazioni di questo tipo, quanto possano essere problematiche quelle famiglie nella quale la confusività (comunicativa, relazionale, di ruoli, di funzioni) sembra pervadere tutti i livelli. Diverse scene contengono messaggi assolutamente incongruenti tra loro. Ho già accennato, per esempio, al fatto che questa famiglia sia dedita al crimine. In una scena assistiamo ad un diverbio molto acceso, sul fatto che dopo essere andato in bagno, uno degli zii non si sia lavato le mani. Quali regole funzionano? Solo quelle della famiglia stessa? In una scena successiva li vediamo mentre fumano all’interno di un locale pubblico. Sembra allora che questa famiglia abbia in qualche maniera costruito delle sue regole. E fin qui non ci sarebbe nulla di male dal momento che ogni sistema familiare è portatore di una sua visione e di sue regole. La discrepanza è rintracciabile nel momento in cui le regole della famiglia sembrano assolutamente slegate dal contesto nella quale la famiglia vive o, comunque, slegate dal contesto sociale generale. Questo provoca una sorta di autoreferenzialità assolutamente sconcertante. L’incongruenza di cui parlo viene accentuata da moltissimi episodi all’interno del film: i tre figli della donna si picchiano tra loro quasi fossero ragazzini e la madre li sgrida proprio come se fossero piccoli. Sembra una fotografia congelata di tempi ormai passati. Ma che per questa famiglia sono tragicamente il presente. Oppure le reazioni della donna, quando un amico dei tre viene ucciso dalla polizia. La madre cerca di consolare il figlio che piange proprio come farebbe se lui fosse un bambino.
Anche il racconto della donna su come la figlia (madre di J) sia uscita fuori dalla famiglia assume contorni particolari. La donna spiega come abbia lasciato la figlia per una regola non rispettata in un gioco a carte in cui i giocatori erano ubriachi. Lo racconta con una incongruenza totale tra il modo in cui il racconto avviene e il fatto in sé. Come se stesse parlando di sciocchezze e non della sua stessa figlia. Questo sistema, nella sua autoreferenzialità, è del tutto isolato dall’esterno. Non solo hanno regole loro, ma nessuno di loro sembra avere una relazione con altre persone. Anzi, nel momento in cui l’esterno entra in casa, il sistema familiare si attiva affinché possa ben presto lasciarlo. Qualunque tentativo del mondo esterno di entrare viene bloccato. Naturalmente vale anche il contrario e viene bloccato nello stesso modo anche qualunque tentativo di uscire da questa famiglia. E in quest’ottica, quella di non poter uscire, di non poter avere autonomia, quel patto non scritto per cui o si sta dentro o si muore, che leggo anche la morte dell’unica figlia uscita di casa, la mamma di J. Perché non sopravvive? Perché estromessa dal suo clan? E la sua morte è forse il modo per far rientrare il figlio e ‘lavare’ così la colpa di essere uscita?
E la fine è altrettanto tragica di quanto fin qui raccontato. La famiglia non salva e, anzi, porta J a legarsi, in qualche modo in maniera indissolubile con i suoi zii. Ripeto, è un film molto disturbante, violento. Può infastidire molto, quindi ne consiglio la visione solo se si tiene conto della tematica trattata. Credo sia un esempio, un pessimo esempio, di come il mancato confronto, l’interazione e la mediazione di regole, di prospettive diverse, possano portare alla follia di una visione che tutto giustifica e tutto consente. Anche se tutto questo ha come teatro e avviene per la propria famiglia.
A presto…
Tutti i diritti riservati

 Anche se passato sotto silenzio, dato che non mi piace molto festeggiare i compleanni, questo mese ha segnato il secondo compleanno del blog. Nacque, infatti, il 1 di Marzo del 2011. Da allora molte cose sono successe, tante cose sono state pubblicate, tanti punti di discussione, incontri e scontri, molto spesso argomentati, altre volte veri e propri inutili insulti, che ho provveduto a pubblicare perché non mi si potesse accusare di mettere solo commenti a me graditi. Tanti, col tempo che passa, continuano a chiedermi chi me lo faccia fare, chi mi ‘costringa’ a coltivare un vero e proprio secondo lavoro che consiste non solo nello scrivere, quanto nell’organizzare la serie di articoli o di riferimenti che poi utilizzo per scrivere gli articoli stessi. La verità è che non saprei rispondere.
Anche se passato sotto silenzio, dato che non mi piace molto festeggiare i compleanni, questo mese ha segnato il secondo compleanno del blog. Nacque, infatti, il 1 di Marzo del 2011. Da allora molte cose sono successe, tante cose sono state pubblicate, tanti punti di discussione, incontri e scontri, molto spesso argomentati, altre volte veri e propri inutili insulti, che ho provveduto a pubblicare perché non mi si potesse accusare di mettere solo commenti a me graditi. Tanti, col tempo che passa, continuano a chiedermi chi me lo faccia fare, chi mi ‘costringa’ a coltivare un vero e proprio secondo lavoro che consiste non solo nello scrivere, quanto nell’organizzare la serie di articoli o di riferimenti che poi utilizzo per scrivere gli articoli stessi. La verità è che non saprei rispondere.