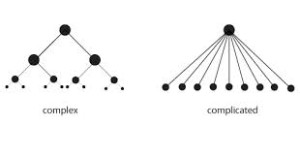Chi di noi non ha letto il Piccolo Principe? Considerato, riduttivamente, uno dei testi fondamentali della letteratura per ragazzi, credo sia uno dei testi più complessi per la molteplicità dei punti di vista dal quale può essere colto. Letto per la prima volta a scuola, l’ho ripreso diverse volte nel corso degli anni, trovandoci sempre suggestioni diverse. Ho come l’impressione che il libro cresca insieme a me, che non sia statico e finito ma mi permetta, in spazi e tempi diversi, di cogliere riferimenti e muovermi tra suggestioni che nella lettura precedente non avevo colto. Tra le varie riletture diventavo (come ormai saprete!) psicologo specializzandomi, poi, in psicoterapia familiare. L’ho (per caso?) ripreso in mano qualche giorno fa per rileggerlo, curioso di capire cosa mi avrebbe comunicato in questa fase della vita. E, ovviamente, non sono stato deluso. Tralasciando la complessità dei riferimenti sempre presenti nel testo, la suggestione in questa lettura è stata nel rapporto tra il bambino e la volpe, associando la descrizione di questo rapporto, alla costruzione della relazione terapeutica.
Chi di noi non ha letto il Piccolo Principe? Considerato, riduttivamente, uno dei testi fondamentali della letteratura per ragazzi, credo sia uno dei testi più complessi per la molteplicità dei punti di vista dal quale può essere colto. Letto per la prima volta a scuola, l’ho ripreso diverse volte nel corso degli anni, trovandoci sempre suggestioni diverse. Ho come l’impressione che il libro cresca insieme a me, che non sia statico e finito ma mi permetta, in spazi e tempi diversi, di cogliere riferimenti e muovermi tra suggestioni che nella lettura precedente non avevo colto. Tra le varie riletture diventavo (come ormai saprete!) psicologo specializzandomi, poi, in psicoterapia familiare. L’ho (per caso?) ripreso in mano qualche giorno fa per rileggerlo, curioso di capire cosa mi avrebbe comunicato in questa fase della vita. E, ovviamente, non sono stato deluso. Tralasciando la complessità dei riferimenti sempre presenti nel testo, la suggestione in questa lettura è stata nel rapporto tra il bambino e la volpe, associando la descrizione di questo rapporto, alla costruzione della relazione terapeutica.
In generale, in ogni relazione abbiamo l’incontro di due mondi che si incontrano. La peculiarità della relazione terapeutica è forse quella che quest’ultima ha (o dovrebbe avere!) come fine la maggiore coscienza di se stessi. La relazione terapeutica è particolare perché uno dei capisaldi è la non totale reciprocità nel rapporto, aspetto che la differenzia da un rapporto amicale. È una relazione nella quale dovrebbero svolgere un ruolo determinante diversi fattori: la capacità di costruire una relazione, l’accoglienza del terapeuta, la presenza di empatia, la mancanza di giudizio per le vicende del paziente, la pazienza, la responsabilità. E forse vi starete chiedendo: come si lega questo con la storia del Piccolo Principe? Proviamo a vederlo assieme.
Ad un certo punto nella storia, il piccolo principe incontra nel suo percorso una volpe (che poi diventa LA volpe, ma ci arriveremo…) e inizia un dialogo con l’animale. Inizialmente il piccolo principe chiede alla volpe di giocare con lui, ma la volpe gli risponde che non lo può fare perché non è addomesticata e, nella sua infinita saggezza istintuale, chiede al piccolo di addomesticarla. Il piccolo principe chiede alla volpe cosa significhi addomesticare. La volpe gli risponde che vuol dire creare dei legami. Spiegando ancora:
“Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremmo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”
Primo passo nella relazione è proprio quella dell’addomesticamento, la possibilità cioè di stabilire una relazione. La relazione terapeutica può essere basata, inizialmente, sul bisogno, sulla necessità. Da questo primo movimento può nascere, con costanza, fiducia e impegno, una relazione basata sull’importanza e non più esclusivamente sull’urgenza. Altro elemento presente in questo passo è l’unicità nella relazione, il momento nel quale si ha il passaggio dall’essere una volpe tra le volpi per diventare LA volpe con la quale si intrattiene un rapporto, un riconoscimento reciproco del ruolo che ognuno di noi assume per l’altro. Questo passaggio è necessario nel momento in cui, come dice la volpe, “non si conoscono le cose se non si addomesticano”, non si riesce a comprendere una realtà con le quali non si è riusciti a stabilire una relazione. L’addomesticamento è un processo a doppio senso, non interessa solo uno dei due membri, per quanto la relazione terapeutica sia apparentemente sbilanciata dal disvelamento su un lato (il paziente) e un disvelamento minore dall’altro (il terapeuta). Ma la creazione del legame è reciproca. Ed è unica. L’unicità nella/della relazione è un principio fondamentale. Il paziente è consapevole che ogni terapeuta veda altre persone, ma deve avere la sicurezza che al momento in cui noi siamo con lui, siamo totalmente presenti e centrati sulla relazione che in quel momento abbiamo nel rapporto con lui:
“(…) Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell’oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano…”
La relazione ha la capacità di significare il nostro mondo. All’interno della relazione le cose acquistano un diverso valore e un campo di grano, che non ricordava nulla alla volpe, diventa significativo nel momento in cui viene associato al colore dei capelli del bimbo. È la relazione col piccolo principe a dare senso al grano. Così, nella relazione terapeutica, è la relazione stessa la base del cambiamento di senso del mondo del paziente.
Uno degli aspetti più rilevanti per l’addomesticamento è sicuramente la pazienza:
“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino…”
L’avvicinamento è costante e graduale. La relazione, qualunque essa sia, è inizialmente fondata sulle parole. Ma da subito, ad un livello che non riusciamo neanche a capire e spiegare, possono intervenire fattori non legati esclusivamente alla comunicazione verbale. Sappiamo subito, a pelle, se una persona può piacerci oppure no. È un aspetto inconscio che nella relazione terapeutica è basato anche sulla fiducia, sull’empatia, sull’accoglienza, sulla mancanza di giudizio.
Altro aspetto rilevante nello strutturare la relazione terapeutica è la costanza:
“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora”, disse la volpe. “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai ancora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti”
Come accennato, la costanza è una parte rilevante nella strutturazione della relazione terapeutica. È necessario il rispetto di alcune regole nella costruzione della relazione, che all’inizio appaiono costrittive ma che strutturano la costruzione relazionale della stessa. È necessario prepararsi il cuore prima dell’incontro? Io credo di si, credo sia necessario ‘sintonizzare’ il proprio cuore con quello della persona che deve venire. E questo ha a che fare con l’unicità nella relazione terapeutica stessa:
“Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente,” disse. “Nessuno vi ha addomesticato, e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora per me unica al mondo”.
Nessuna rosa/persona è uguale all’altra, e solo il suo addomesticamento, la costruzione di una relazione con essa, permette di dare un significato a quella rosa/persona.
Ma qual è il fine della relazione terapeutica? Io credo che l’obiettivo sia la costruzione di una maggiore consapevolezza della persona e la si può ottenere accompagnando la persona stessa nell’esplorazione del suo mondo interiore, l‘anima:
“Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”
La costruzione del rapporto può avvenire anche in maniera non verbale, ma istintuale e inconscia, senza mediazione visiva o linguistica. Chiave di accesso per questo mondo è una delle doti fondamentali del terapeuta l’empatia, la capacità cioè di relazionarsi intimamente con l’altro, avvicinandosi al suo sentire, accogliendolo e comprendendolo, dando la possibilità all’altro di far emergere e condividere la sua realtà interiore.
All’interno della relazione terapeutica altro spazio fondamentale è la responsabilità:
“Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa”
Ho fatto mia questa frase. Mi sento pienamente responsabile, anche a distanza di tempo, delle rose che ho avuto la fortuna di incontrare in tutti questi anni di professione. Ho cercato di stabilire una connessione con ognuna di loro, addomesticandole e venendone addomesticato.
Anche nella relazione terapeutica può arrivare, come in ogni relazione, il momento di separazione, un momento nel quale il cammino di due persone può portarle ad allontanarsi l’una dall’altra. È un momento importante, spesso etichettato come triste:
“Ah!” disse la volpe, “… piangerò”.
“La colpa è tua”, disse il piccolo principe, “io, non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi…”.
“È vero”, disse la volpe.
“Ma piangerai!” disse il piccolo principe.
“È certo”, disse la volpe…
“Ma allora che ci guadagni?”
“Ci guadagno”, disse la volpe, “il colore del grano”.
Ci si può focalizzare su due momenti alla fine della relazione: il momento della perdita, il fatto che le cose ‘stiano finendo’, ma ci si può concentrare anche sulla gratitudine dell’incontro, sull’essersi trovati. Le persone tendono a focalizzare la loro attenzione sul primo aspetto, scordandosi di quanto ci si è arricchiti nell’incontro. Anche questo essenziale è invisibile agli occhi ed è il concetto stesso di perdita che altera l’idea dell’incontro. Non c’è perdita, né di relazione, né di tempo. D’altronde:
“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”
E se il tempo che abbiamo dedicato loro le ha rese così importanti non si comprende dove sia la perdita!
“Poi soggiunse:
“Và a riveder le rose. Capirai che la tua è unica al mondo” [1]
E sono sempre più convinto che ognuna delle rose che ho (e mi hanno) addomesticato sia unica al mondo.
A presto…
Fabrizio Boninu
[1] Antoine De Saint-Exupéry (1949), Il Piccolo Principe, Bompiani, Milano pp. 91-98
Tutti i diritti riservati

Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?
Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.
Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.
 Questo post ha bisogno di una piccola/grande premessa che inizia dalla visione di un film: Hannah Arendt (2012). Il film narra la vita di Hannah Arendt tra il 1960 e il 1964. In quel periodo la Arendt ha circa cinquant’anni, ed è un’intellettuale di origine tedesca, naturalizzata statunitense per sfuggire alle persecuzioni naziste nei confronti degli ebrei della seconda guerra mondiale. Nel 1961 la rivista The New Yorker la mandò a Gerusalemme come cronista di quello che si annunciava come uno dei processi del secolo: il caso di Adolf Eichmann, uno dei più grandi criminali nazisti, catturato in Argentina e processato da un tribunale ebraico (e, per la cronaca, condannato a morte nel 1962). Da intellettuale prestata alla ‘cronaca’, la Arendt approfittò del punto di vista privilegiato che aveva sulla vicenda per una profonda riflessione circa la mancanza di mostruosità nella persona di Eichmann, sulla sua presunta normalità, sulla impossibilità di pensare che quel piccolo ometto calvo e con gli occhiali potesse essere non un burocrate ma una delle personificazioni del male per come lo aveva conosciuto il mondo pochi anni addietro. La riflessione portò la Arendt a scrivere uno dei suoi libri più famosi, La banalità del male, libro nel quale affronta appunto la banalità del male che ci circonda, dovuto non a casi eccezionali o a predisposizioni particolarmente malvagie e sanguinarie delle singole persone, quanto dell’inconsapevolezza che le scelte, anche piccole di ognuno di noi, hanno nel costruire un risultato disastroso quanto quello che si era creato durante la seconda guerra mondiale.
Questo post ha bisogno di una piccola/grande premessa che inizia dalla visione di un film: Hannah Arendt (2012). Il film narra la vita di Hannah Arendt tra il 1960 e il 1964. In quel periodo la Arendt ha circa cinquant’anni, ed è un’intellettuale di origine tedesca, naturalizzata statunitense per sfuggire alle persecuzioni naziste nei confronti degli ebrei della seconda guerra mondiale. Nel 1961 la rivista The New Yorker la mandò a Gerusalemme come cronista di quello che si annunciava come uno dei processi del secolo: il caso di Adolf Eichmann, uno dei più grandi criminali nazisti, catturato in Argentina e processato da un tribunale ebraico (e, per la cronaca, condannato a morte nel 1962). Da intellettuale prestata alla ‘cronaca’, la Arendt approfittò del punto di vista privilegiato che aveva sulla vicenda per una profonda riflessione circa la mancanza di mostruosità nella persona di Eichmann, sulla sua presunta normalità, sulla impossibilità di pensare che quel piccolo ometto calvo e con gli occhiali potesse essere non un burocrate ma una delle personificazioni del male per come lo aveva conosciuto il mondo pochi anni addietro. La riflessione portò la Arendt a scrivere uno dei suoi libri più famosi, La banalità del male, libro nel quale affronta appunto la banalità del male che ci circonda, dovuto non a casi eccezionali o a predisposizioni particolarmente malvagie e sanguinarie delle singole persone, quanto dell’inconsapevolezza che le scelte, anche piccole di ognuno di noi, hanno nel costruire un risultato disastroso quanto quello che si era creato durante la seconda guerra mondiale.