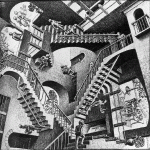Il post di oggi ha a come obiettivo quello di cercare di delineare quelle che sono le diverse ‘tendenze’ all’interno di un percorso di terapia. Molti spesso credono che ci sia un solo modo di fare terapia, come se uno psicoterapeuta, una volta che ha imparata una tecnica, la potesse pedissequamente applicare ad ogni persona con la quale ha la fortuna di trovarsi a lavorare. In realtà la ‘materia’ della psicoterapia, la persona o il gruppo con cui si lavora, è materia liquida, complessa, ed è per questo che non si può fare a priori una definizione o una delineazione di quello che succederà in terapia, data la costruzione stessa del rapporto terapeutico che non può essere inquadrato in regole o in classi. E’ possibile, ed è questo che proviamo a fare oggi, cercare di delineare uno ‘stile’ di terapia, un modus operandi che il terapeuta applica all’interno del suo lavoro. Questo post è basato sulle posizioni e sulle considerazioni dello psicoterapeuta americano Carl Whitaker che nel suo bellissimo libro Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia, cerca di delineare alcune riflessioni su cosa voglia dire essere uno psicoterapeuta e su come questo mestiere debba interagire con l’altro. Vi riporto i tre modi con cui Whitaker cerca di delineare degli ‘stili di terapia:
Il post di oggi ha a come obiettivo quello di cercare di delineare quelle che sono le diverse ‘tendenze’ all’interno di un percorso di terapia. Molti spesso credono che ci sia un solo modo di fare terapia, come se uno psicoterapeuta, una volta che ha imparata una tecnica, la potesse pedissequamente applicare ad ogni persona con la quale ha la fortuna di trovarsi a lavorare. In realtà la ‘materia’ della psicoterapia, la persona o il gruppo con cui si lavora, è materia liquida, complessa, ed è per questo che non si può fare a priori una definizione o una delineazione di quello che succederà in terapia, data la costruzione stessa del rapporto terapeutico che non può essere inquadrato in regole o in classi. E’ possibile, ed è questo che proviamo a fare oggi, cercare di delineare uno ‘stile’ di terapia, un modus operandi che il terapeuta applica all’interno del suo lavoro. Questo post è basato sulle posizioni e sulle considerazioni dello psicoterapeuta americano Carl Whitaker che nel suo bellissimo libro Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia, cerca di delineare alcune riflessioni su cosa voglia dire essere uno psicoterapeuta e su come questo mestiere debba interagire con l’altro. Vi riporto i tre modi con cui Whitaker cerca di delineare degli ‘stili di terapia:
Il primo è l’eliminazione del sintomo. Il paziente la famiglia arrivano in uno stato di carenza emotiva, simili a bambini indifesi, insicuri ed incapaceidi agire, per mancanza di nutrimento, di forza, di opportunità di crescita. La risposta più ovvia a questi sintomi è l’offerta di nutrimento e di cure di una madre affidataria. Il rapporto che si crea è molto simile a quello di un maestro che incoraggia il bambino a leggere, studiare, a imparare, a creare, stimolandolo sempre di più ad apprendere. Uno dei problemi principali che derivano da questo atteggiamento è la sindrome ‘mamma sa tutto’.
Il terapeuta escogita sempre nuovi trucchi per cambiare le cose, ma finisce per far perdere completamente al paziente la libertà di prendere iniziative. Questo significa che il paziente e la famiglia diventano sempre più dipendenti e dubitano sempre di più di se stessi, mettendo il genitore affidatario nella temporanea ma gratificante situazione di essere un Dio onnipotente. A quel punto il genitore affidatario deve trovare il sistema per risolvere una situazione simile, per molti aspetti, a quella che di un bambino nel distaccarsi dalla famiglia, in un’età in cui ha ancora bisogno di dare e di ricevere affetto. [1]
Il primo modo è il modo in apparenza più semplice. Si tratta di delineare all’interno della relazione chi sa (il terapeuta) e chi non sa (il paziente). Chi sa deve prodigarsi affinché chi non sa abbia una soluzione al problema per il quale è venuto e ha iniziato una terapia. Questo porta a due conseguenze entrambe pericolose se non maneggiate con consapevolezza dal terapeuta: chi non sa ottiene una soluzione a sua misura, ma indirettamente riceve la conferma che se non ci fosse stato l’intervento del terapeuta non avrebbe saputo come fare e quindi rinforza in se stesso l’idea di non ‘saper fare’ autonomamente.
Il terapeuta può, invece, crogiolarsi nel ruolo di colui che ‘sa come/cosa fare’, crederci in blocco e passare dalla posizione aperta di terapeuta (ti aiuto ad aiutarti) alla posizione chiusa di guru (fai come ti dico). In questa posizione la libertà del paziente è messa a dura prova, perché penserà di avere sempre bisogno del supporto del terapeuta per poter procedere, mentre l’onnipotenza del terapeuta ne uscirà rafforzata perché si alimenterà di un nuovo caso nel quale i suoi consigli hanno apparentemente risolto la situazione. Credo che questo, se il terapeuta non è consapevole di ciò che sta avvenendo, non sia un buon modo di fare terapia per varie ragioni: non si rende indipendente il paziente all’interno delle sue scelte e si coltiva la disparità di ruolo all’interno della relazione terapeutica (io terapeuta so vs. tu, paziente non sai).
– Continua –
[1]Whitaker, C. (1989), Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia, Astrolabio, Roma, pag. 173
Tutti i diritti riservati