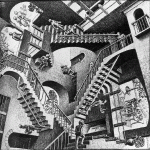 Molte persone, quando scoprono che sono psicologo, mi dicono che non capiscono che tipo di lavoro faccia. Suppongo abbiano in mente una conversazione tra due persone che, amabilmente, si raccontano le loro cose. Se una persona viene da me per parlare non può parlare con un suo amico, che lo ascolta gratis e può dare dei consigli basati sul buon senso oltreché su una conoscenza più approfondita?
Molte persone, quando scoprono che sono psicologo, mi dicono che non capiscono che tipo di lavoro faccia. Suppongo abbiano in mente una conversazione tra due persone che, amabilmente, si raccontano le loro cose. Se una persona viene da me per parlare non può parlare con un suo amico, che lo ascolta gratis e può dare dei consigli basati sul buon senso oltreché su una conoscenza più approfondita?
Ovviamente, non credo che l’avere amici che ci ascoltano e che ci possano dare dei suggerimenti possa essere una cosa negativa, ma la relazione che si instaura tra terapeuta e paziente è molto diversa. Cercherò di spiegare quali sono a mio avviso le differenze. Primo per certe questioni un amico può non essere obiettivo. Un amico fa parte della nostra vita, ha condiviso con noi alcune scelte, non ne ha condivise altre. Non è esterno come potrebbe essere uno psicologo. Questo punto è molto importante tanto che uno psicologo, per lo stesso motivo, difficilmente prenderà in carico un suo parente o un suo amico. Secondo, il rapporto con uno psicologo è basato essenzialmente sulla asimmetria della relazione: una persona parla delle sue cose più intime, l’altro no. Nell’amicizia, si presuppone, questa asimmetria sia molto meno marcata. Questa asimmetria marca il contesto della relazione come altra cosa rispetto a tutte le altre relazioni. La specificità della relazione terapeutica è marcata anche da un altro fattore: il tempo. Spero non abbiate amici che vi concedono solo un’ ora per di più a pagamento!
Ultimo punto, che secondo me fa veramente la differenza, credo sia il fatto che uno psicologo non dovrebbe dare consigli. “E per cosa lo pago” vi chiederete? I consigli, abbiamo già visto, li otterreste gratis dai vostri amici. Personalmente, non mi sembra corretto che mi sostituisca alla persona e le dica cosa deve o non deve fare. Non sono così presuntuoso da ritenere di avere le chiavi o di poter pilotare la vita di un’altra persona. Credo che il compito di un bravo professionista sia quello di mostrare delle alternative in situazioni che sembrano cristallizzate da tempo. Data l’alternativa, ritengo che la scelta debba necessariamente ricadere sull’interessato.
Non lasciatevi ingannare: non è assolutamente un compito da poco. Talvolta accettare una prospettiva nuova su storie che sono ormai assodate e date per scontate da tempo richiede un enorme sforzo. E’ meno impegnativo adagiarsi su una storia ormai accettata piuttosto che doversi impegnare nel ristrutturare modelli e archetipi ormai fissati. Anche se questa storia ci imprigiona, spesso una persona preferisce una gabbia comoda ad una realtà nuova con cui confrontarsi.
Questa è la mia visione del percorso terapeutico: dare alla persona, o alla famiglia, un’alternativa che permetta la scelta. Magari si rimarrà all’interno della gabbia, ma con la consapevolezza che fuori esista un’altra prospettiva. E un conto è essere prigionieri di una gabbia un conto è scegliere di rimanerci dentro. Nel secondo caso ci sarà stata una scelta che prima non si sentiva di poter fare.
Cosa ne pensate?
A presto…
Tutti i diritti riservati



Salve Sonya benvenuta sul blog.. Ovviamente condivido in pieno le parole di Whitaker. Il mio intento era quello di marcare una differenziazione tra contesto psicologico e contesto amicale, con questo non volendo sminuire il valore fondamentale delle relazioni nella vita di una persona. Ho usato la parola scelta nel senso di predilezione non perché pensi che qualcuno possa scegliere consapevolmente di compiere un azione autodistruttiva, quanto perché, nel momento in cui viene fornita un’alternativa, si palesa una possibilità di scelta. Certo, sarà una scelta non del tutto libera perché influenzata da un insieme di livelli, tra i quali quelli da lei menzionati. Ma la persona potrà determinare a quale di questi livelli dare più peso. In questo, penso, ci sarà scelta. Grazie per l’ottimo commento. A presto…
Carl Whitaker, in Considerazioni Notturne, uno dei libri più belli che abbia mai letto, definiva “incontri terapeutici” quelli sani, costruttivi, pro-individuazione, che appartengono al quotidiano possibile di un individuo. Definiva così l’incontro con la moglie, per esempio. Può esserlo quello con un amico, che non è detto debba per forza comportarsi come un dispensatore di consigli. Può essere così evoluto da sapere che non servono. Può esserlo al punto da riuscire a giocare con il contesto muovendosi con destrezza, tra soggettività (affettività) e oggettività (distanziamento). La relazione terapeutica professionale, sosteneva sempre Whitaker (che sottoscrivo in toto) arriva spesso, quando le altre relazioni falliscono il loro intento fondante, quello di essere terapeutiche, ossia fondanti positivamente, per l’individuo.
La parola scelta, riferita alla rinuncia ad uscire da una gabbia, ritengo sia impropria. Nessuno sceglie nel senso vero del termine, di compiere un’azione autodistruttiva. Si tratta di una volontarietà relativa. Falsata. Regolata da tanti, troppi livelli, personali, individuali, relazionali (in qualche punto nodale evidentemente disfunzionali).
Saluti