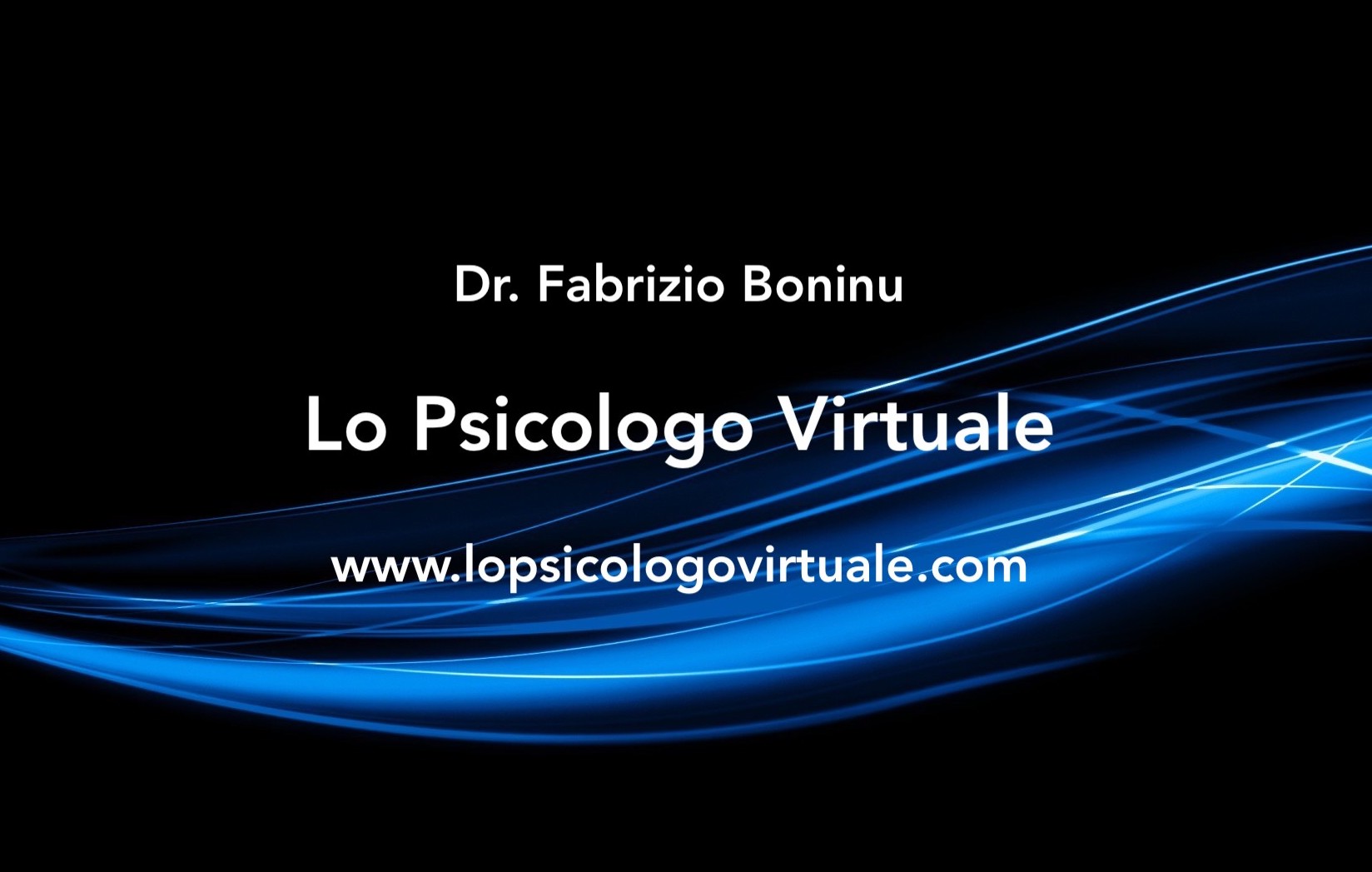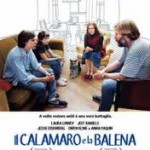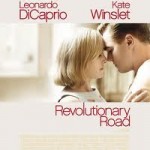L’articolo del quale voglio parlarvi oggi riguarda una realtà che è sotto gli occhi di tutti noi. Mi riferisco all’aumento spropositato di persone che soffrono di disturbo da gioco, vera e propria nuova mania nazionale aggravato, per molti, anche dalle condizioni economiche di questo periodo. Ma andiamo con ordine. Secondo la Alea, associazione per lo studio del gioco, sarebbero mezzo milione le persone che avrebbero un rapporto patologico con il gioco. Ci si riferisce a persone che non sono in grado di controllare l’impulso di giocare, che non sono in grado di smettere autonomamente e che sono in grado, invece, di passare ore e ore di fronte a macchinette o giocarsi l’intero stipendio (o pensione) nella speranza di poter guadagnare qualcosa. Di questi 500.000 ben 100.000 sarebbero minorenni, persone che non potrebbero neanche giocare. Non ci si deve stupire di questi numeri: i minorenni vengono iniziati al gioco tramite delle apparentemente innocue applicazioni che spopolano, per esempio, su Facebook. Questi giochi, anche se apparentemente non sono dannosi perché non si vince o non si perde nulla se non ‘soldi virtuali’, in realtà sono potenzialmente molto distruttive nel momento in cui iniziano ad innescare nel minore sia la comprensione che la passione per il gioco fine a se stesso. Quel minore sarà, poi, un adulto che conoscerà non solo tutte le regole del gioco ma avrà provato l’ebbrezza di vincere e perdere virtualmente. Il salto nel reale è solo l’ultimo passo per una dipendenza coltivata da anni.
L’articolo del quale voglio parlarvi oggi riguarda una realtà che è sotto gli occhi di tutti noi. Mi riferisco all’aumento spropositato di persone che soffrono di disturbo da gioco, vera e propria nuova mania nazionale aggravato, per molti, anche dalle condizioni economiche di questo periodo. Ma andiamo con ordine. Secondo la Alea, associazione per lo studio del gioco, sarebbero mezzo milione le persone che avrebbero un rapporto patologico con il gioco. Ci si riferisce a persone che non sono in grado di controllare l’impulso di giocare, che non sono in grado di smettere autonomamente e che sono in grado, invece, di passare ore e ore di fronte a macchinette o giocarsi l’intero stipendio (o pensione) nella speranza di poter guadagnare qualcosa. Di questi 500.000 ben 100.000 sarebbero minorenni, persone che non potrebbero neanche giocare. Non ci si deve stupire di questi numeri: i minorenni vengono iniziati al gioco tramite delle apparentemente innocue applicazioni che spopolano, per esempio, su Facebook. Questi giochi, anche se apparentemente non sono dannosi perché non si vince o non si perde nulla se non ‘soldi virtuali’, in realtà sono potenzialmente molto distruttive nel momento in cui iniziano ad innescare nel minore sia la comprensione che la passione per il gioco fine a se stesso. Quel minore sarà, poi, un adulto che conoscerà non solo tutte le regole del gioco ma avrà provato l’ebbrezza di vincere e perdere virtualmente. Il salto nel reale è solo l’ultimo passo per una dipendenza coltivata da anni.
Parlando di gioco, non stiamo parlando, ovviamente, solo di macchinette o poker, ma di tutti quei mille modi con cui le persone tentano la fortuna in Italia: gratta e vinci in primis. Ormai sono talmente diffusi che sembra impossibile uscire da un negozio qualunque senza averne giocato almeno uno. Promettono premi sempre più grossi e alcuni propongo dei veri e propri vitalizzi. La tentazione si fa sempre più grossa sopratutto per quelle fasce sociali che, invece, hanno sempre più difficoltà ad arrivare a fine mese. Non stupisce, allora, come tra le categorie di giocatori più a rischio vengano citati pensionati, casalinghe, disoccupati, fasce deboli della popolazione e che queste categorie costituiscano addirittura il 40% dei giocatori più a rischio di sviluppare dipendenza.
Sono dati allarmanti considerato che spendiamo mediamente 8o miliardi di euro all’anno per giochi, gratta e vinci, scommesse e lotterie. Lo Stato è il vero vincitore di questo giro immenso di soldi. Si calcola che incassi all’incirca 20 miliardi di euro l’anno. Prima di pensare che questa cifra giustifichi e spieghi l’investimento, bisognerebbe forse, pensare a tutti i costi, materiali, psicologici, sociali che questo tipo di dipendenza invece comporta per le stesse casse dello Stato. Molte di queste persone, non essendo in grado di uscire autonomamente dalla dipendenza, hanno bisogno di aiuto qualificato e si rivolgono ai servizi psicosociali delle Asl, andando ad aumentare il grado di congestione del servizio stesso. Molti, spinti dal miraggio della ricchezza, si ritrovano ad essere sempre più poveri. In alcune fasce questo potrebbe provocare l’aumento di tensione familiare, coniugale, genitoriale. Sono tutti costi imponderabili, ma che sarebbe bene mettere sul piatto della bilancia. Solo allora risulterebbe difficile lavarsi la coscienza con il ritornello gioca il giusto!
Intanto il link:
http://www.repubblica.it/salute/2012/03/23/news/giocodipendenza_6mila_italiani_in_cura-32078025/
L’articolo è di Repubblica ed è firmato da Caterina Pasolini
A presto…
Tutti i diritti riservati