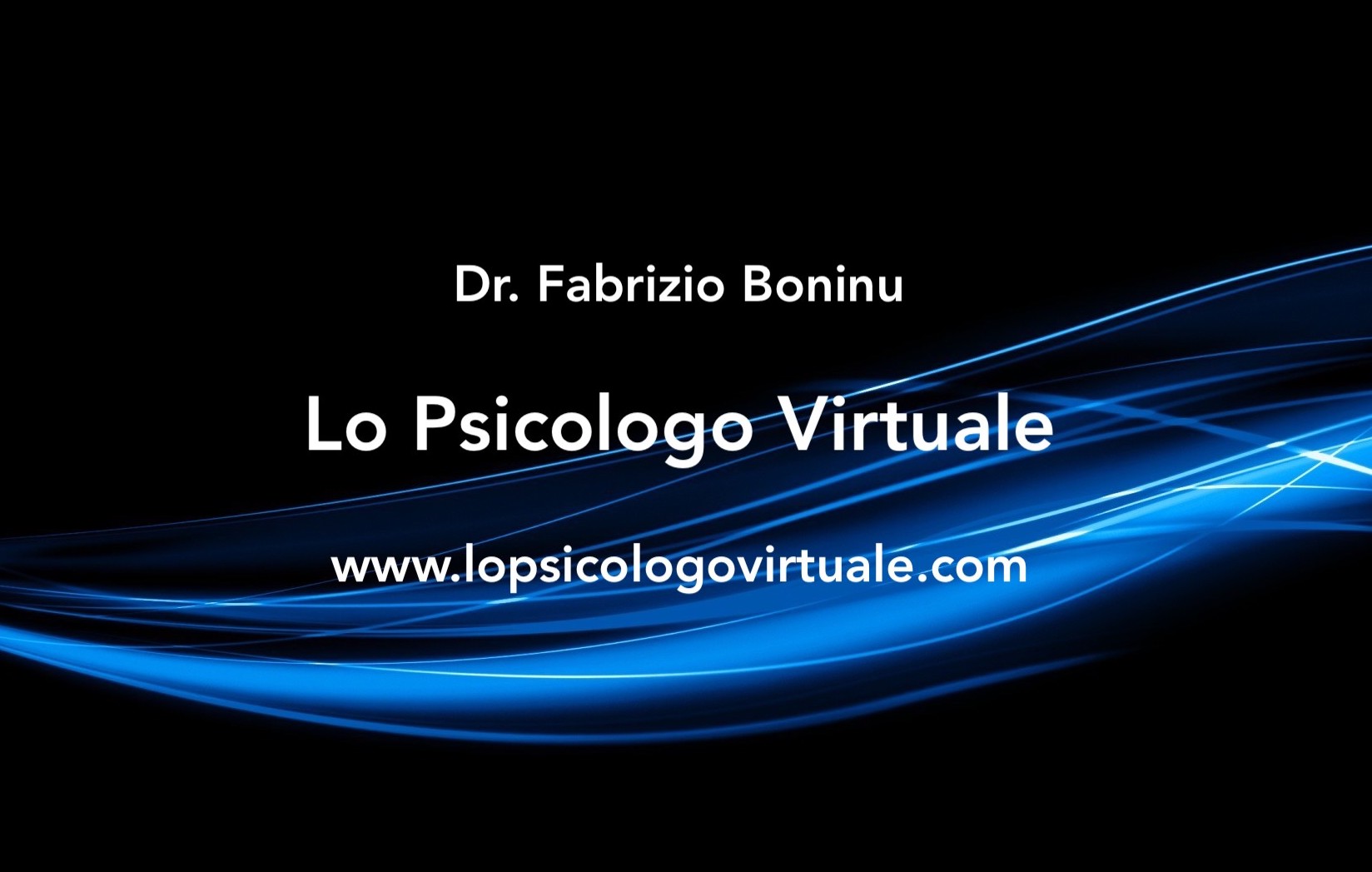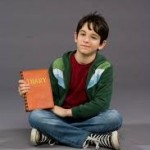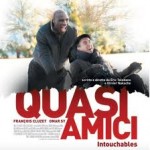Anche quest’anno scolastico è finito. Un anno scolastico caratterizzato dalle solite polemiche sul funzionamento buono o meno buono di una realtà con la quale tutti, a diversi gradi, siamo chiamati in qualche modo a dover interagire. Quest’anno, complice un progetto di collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile della Asl 8 di Cagliari, ho avuto modo di guardare a questa realtà molto da vicino avendo idea che ci siano tante cose buone e tante cose che, invece, continuano a non funzionare. Ovviamente il mio discorso riguarda specificamente la realtà di Cagliari che ho conosciuto da vicino, ma credo che alcuni punti possano essere comuni con altre realtà scolastiche. Credo che il nodo problematico principale sia quello di una carenza di comunicazione tra i diversi livelli. All’interno di una scuola possiamo delineare la presenza di almeno tre livelli: il livello degli insegnanti (I), il livello dei genitori (G), il livello degli alunni (A). Ne esistono altri (dirigenza, operatori scolastici..) ma ci limiteremo a prendere in considerazione gli attori principali. In un’ottica che potremo definire lineare possiamo immaginare che la comunicazione avviene, tra i diversi livelli, con un passaggio che potremmo definire consequenziale e che potremmo rappresentare graficamente così: A → G → I. In realtà la comunicazione è molto più complessa e provoca reazioni ad ogni livello.
Anche quest’anno scolastico è finito. Un anno scolastico caratterizzato dalle solite polemiche sul funzionamento buono o meno buono di una realtà con la quale tutti, a diversi gradi, siamo chiamati in qualche modo a dover interagire. Quest’anno, complice un progetto di collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile della Asl 8 di Cagliari, ho avuto modo di guardare a questa realtà molto da vicino avendo idea che ci siano tante cose buone e tante cose che, invece, continuano a non funzionare. Ovviamente il mio discorso riguarda specificamente la realtà di Cagliari che ho conosciuto da vicino, ma credo che alcuni punti possano essere comuni con altre realtà scolastiche. Credo che il nodo problematico principale sia quello di una carenza di comunicazione tra i diversi livelli. All’interno di una scuola possiamo delineare la presenza di almeno tre livelli: il livello degli insegnanti (I), il livello dei genitori (G), il livello degli alunni (A). Ne esistono altri (dirigenza, operatori scolastici..) ma ci limiteremo a prendere in considerazione gli attori principali. In un’ottica che potremo definire lineare possiamo immaginare che la comunicazione avviene, tra i diversi livelli, con un passaggio che potremmo definire consequenziale e che potremmo rappresentare graficamente così: A → G → I. In realtà la comunicazione è molto più complessa e provoca reazioni ad ogni livello.
La comunicazione, infatti, non è mai così sequenziale, ed ogni comunicazione ad un livello provoca delle reazioni negli altri livelli. Anche la rappresentazione grafica prima data non sarebbe più molto rappresentativa. Dovremmo forse utilizzare una rappresentazione circolare che sarebbe pressappoco così: A ↔ G ↔ I. Anche questa rappresentazione sarebbe una semplificazione dato che dovremo naturalmente prendere in considerazione anche l’interazione tra insegnanti e alunni. La rappresentazione dovrebbe essere CIRCOLARE. Dovremmo tenerlo a mente quando parliamo di realtà complesse come può essere quella scolastica. Dovremmo considerare il fatto che la comunicazione avviene per più livelli di complessità e che soprattutto è impossibile non comunicare. Questo assioma è stato teorizzato dallo psicologo statunitense Paul Watzlawick nel testo Pragmatica della comunicazione umana.L’assioma sul quale si basano tutti gli altri è appunto quello legato alla possibilità che noi, qualunque cosa facciamo o diciamo, o qualunque cosa non-facciamo o non-diciamo, non possiamo non comunicare qualcosa a coloro i quali ci stanno vicino.
All’interno della scuola, non si può dire che una cosa è avvenuta inspiegabilmente dal momento che i vari sottosistemi hanno comunicato e interagito tra di loro anche se non avrebbero voluto farlo o non avrebbero voluto comunicare tra di loro. Questo avviene a prescindere dalla nostra intenzionalità. Se accettiamo queste premesse non possiamo che verificarne le conseguenze: nessuna nostra azione può non-comunicare con la persona alla quale rivolta. Si tratta solo di darle un valore, un senso, ma questo è soggettivo, dipende cioè dalla persona che emette e da quella che riceve il messaggio. All’interno di quest’ottica in una scuola non si può non comunicare, giusto? E allora perchè parlo delle difficoltà di comunicazione tra i vari livelli? Se è vero che non si possa non-comunicare, è altrettanto vero che questa comunicazione possa essere molto problematica. La problematicità riguarda la differenza di punteggiatura dei messaggi. Con il termine punteggiatura si intende proprio la possibilità che ognuno di noi ha, all’interno di una sequenza comunicativa, di dare valore, esaltare alcune parti a discapito di altre parti della comunicazione stessa. Punteggiare, mettere le virgole dove noi vogliamo vadano messe. Senza pensare che l’altro potrebbe volere le virgole in un altro punto della comunicazione stessa. Questo per dire come sia soggettivo questo processo di punteggiatura nella comunicazione. Il rischio è che si possa credere che la nostra punteggiatura abbia più valore di quella dell’altro. All’interno della realtà scolastica si assiste spesso a questo. Gli insegnanti che, condividendo uno stesso punto di vista, si ‘scontrano’ con la visione della stessa realtà coi genitori che, a loro volta possono scagliarsi contro il mito delle insegnanti che non sanno fare il loro lavoro. Insomma una situazione potenzialmente molto pericolosa dal momento che può portare ad un avvitamento del conflitto su posizioni che sono inconciliabili spesso più apparentemente che realmente.
– Continua –
Tutti i diritti riservati