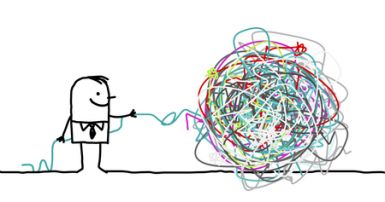 Uno degli interrogativi più importanti, che spesso le persone con le quali lavoro mi chiedono, è quali possano essere considerate le mete, gli obiettivi della terapia. Qual è l’obiettivo che si dovrebbe raggiungere in terapia, quali sono gli scopi, e verso cosa sarebbe necessario tendere nel lavoro? All’interno della cornice sistemica, orientamento psicoterapeutico nel quale sono specializzato, il concetto stesso di malattia è messo in discussione, sostituito dal concetto di significato: un comportamento che sembra ‘malato’ dall’esterno, spesso acquista un senso nel momento in cui ci si rende conto che ha un’utilità all’interno del sistema familiare nel quale viene portato avanti. In quest’ottica epistemologica, questa premessa ha, come necessaria conseguenza, considerare come l’obiettivo della terapia non possa essere la ‘guarigione’, dal momento che non c’è nessuna guarigione da perseguire. L’obiettivo può allora diventare la consapevolezza dei meccanismi che, diventati automatici, sono talmente radicati e istintivi da diventare del tutto inconsapevoli. L’obiettivo può essere quello di una risignificazione, costruire un nuovo significato a ciò che definiamo ‘malato’. Questa presa di coscienza presuppone un cambiamento? Non necessariamente, dal momento che, data maggiore consapevolezza al sistema familiare che lo persegue, la famiglia stessa potrebbe decidere comunque di portare avanti quel tipo di comportamento. Ma allo stesso tempo è vero che qualunque presa di consapevolezza, qualunque riflessione sui modi che sottostanno al comportamento stesso costituisce già di per sé un cambiamento perché porta quel comportamento da uno stato di automatismo ad uno stato di maggiore consapevolezza.
Uno degli interrogativi più importanti, che spesso le persone con le quali lavoro mi chiedono, è quali possano essere considerate le mete, gli obiettivi della terapia. Qual è l’obiettivo che si dovrebbe raggiungere in terapia, quali sono gli scopi, e verso cosa sarebbe necessario tendere nel lavoro? All’interno della cornice sistemica, orientamento psicoterapeutico nel quale sono specializzato, il concetto stesso di malattia è messo in discussione, sostituito dal concetto di significato: un comportamento che sembra ‘malato’ dall’esterno, spesso acquista un senso nel momento in cui ci si rende conto che ha un’utilità all’interno del sistema familiare nel quale viene portato avanti. In quest’ottica epistemologica, questa premessa ha, come necessaria conseguenza, considerare come l’obiettivo della terapia non possa essere la ‘guarigione’, dal momento che non c’è nessuna guarigione da perseguire. L’obiettivo può allora diventare la consapevolezza dei meccanismi che, diventati automatici, sono talmente radicati e istintivi da diventare del tutto inconsapevoli. L’obiettivo può essere quello di una risignificazione, costruire un nuovo significato a ciò che definiamo ‘malato’. Questa presa di coscienza presuppone un cambiamento? Non necessariamente, dal momento che, data maggiore consapevolezza al sistema familiare che lo persegue, la famiglia stessa potrebbe decidere comunque di portare avanti quel tipo di comportamento. Ma allo stesso tempo è vero che qualunque presa di consapevolezza, qualunque riflessione sui modi che sottostanno al comportamento stesso costituisce già di per sé un cambiamento perché porta quel comportamento da uno stato di automatismo ad uno stato di maggiore consapevolezza.
Come si ottiene che si dia l’avvio ad un processo terapeutico?
Tre sono i momenti (…):
1) destabilizzare il sistema ponendosi come campo di forza esterno in grado di provocare o amplificare una fluttuazione, offrendo informazioni alternative e una lettura differente degli accadimenti;
2) impedire che la famiglia proceda nel solito percorso e favorire l’introduzione di informazioni che facilitino il processo di riorganizzazione introducendo una costante;
3) sapersi separare al momento in cui si innesta il processo di riorganizzazione (Fivaz, 1980)[1]
Va fatta una premessa: l’autore fa questo lavoro riferendosi specificamente alla terapia familiare ma credo che il senso sia estendibile anche alle terapie individuali. Il terapeuta, all’interno della terapia familiare, può dunque dare vita a tre momenti diversi: può destabilizzare il sistema offrendo un racconto diverso rispetto a quello che si da la stessa famiglia. Proporre una lettura alternativa a quello che è il racconto della famiglia, può impedire che essa torni o tenda al solito percorso, introducendo in questo modo una costante nuova, una variabile, che possa modificare la visione. Il terapeuta dovrebbe, infine, comprendere quando questo processo è avviato e riuscire a separarsi, favorendo l’autonomia, l’individuazione e l’indipendenza della famiglia.
Un esempio concreto renderà questo discorso più facilmente comprensibile: tempo fa avevo in terapia la famiglia Bianchi, composta da padre, madre e un figlio di 16 anni. Vennero perché il figlio, a loro dire, era particolarmente indisponente, non faceva più nulla di quello che doveva fare, andava male a scuola, frequentava persone che non piacevano ai genitori, aveva iniziato a fumare e così via. Volevano che lo curassi, che lo facessi tornare ‘normale’. Accolsi questa loro richiesta e proposi loro qualche incontro col ragazzo. Il ragazzo che mi si presentò era molto diverso dalla descrizione che me ne era stata data: era un ragazzo disponibile, aperto, molto educato e faticai a riconoscere in lui il ‘mostro’ che mi era stato dipinto.
Pensai, allora, che un incontro con tutti e tre i membri della famiglia assieme potesse far incontrare le diverse visioni che avevano sulla loro stessa famiglia. Nell’appuntamento successivo vennero, dunque, tutti e tre e, per lo meno inizialmente, la seduta si concentrò su quanto il comportamento del figlio fosse l’unica causa del malessere in famiglia. Con tutti i membri del nucleo familiare presenti era però possibile rendere loro l’idea che questo focus così forte sul comportamento del figlio, potesse anche essere un modo per ‘occultare’ qualunque altro movimento all’interno della famiglia. Concentrarsi esclusivamente sul comportamento del figlio rendeva completamente invisibile tutto il resto che riguardava la famiglia e non lasciava molto spazio per i malesseri dei singoli membri. Tentai di passare loro la mia idea che il comportamento del figlio costituisse una sorta di grande distrattore familiare che non permetteva di vedere altro. Cos’altro accadeva in famiglia? Spostando il comportamento del ragazzo dal centro dell’attenzione, vennero fuori aspetti particolarmente interessanti. Il padre era completamente insoddisfatto della sua vita lavorativa e meditava, avendolo di fatto già deciso, di partire all’estero per cercare di fare qualcosa di più interessante oltreché più remunerativo. D’altro lato la madre era completamente insoddisfatta (e spaventata) da questa prospettiva, ed era altrettanto insoddisfatta della piega che stava prendendo la sua vita familiare, dal momento che si apprestava a diventare una madre sola con un figlio adolescente, con un marito lontano per molti mesi all’anno che non avrebbe più potuto occuparsi attivamente dell’educazione del figlio. Al figlio non era stato detto nulla dell’enorme cambiamento che si andava prospettando ma, come tutti voi avrete avuto modo di sperimentare in famiglia, le cose le aveva in qualche modo intuite anche se nulla era stato apertamente ammesso (potremmo aprire una parentesi enorme sulla gestione del dialogo in questa famiglia, soprattutto nei confronti del figlio, ma il tema ci porterebbe troppo lontano dall’idea centrale di questo post). Insomma, una serie di movimenti, dei quali non si poteva neanche parlare, stavano interessando tutto il nucleo familiare. Ecco allora che il comportamento del figlio, concomitante con questa fase di vita familiare, acquista un significato del tutto diverso. Il comportamento del ragazzo ha un senso contrario rispetto al valore che ne veniva dato nella descrizione iniziale: anziché disturbatore della pace familiare, il ragazzo catalizza le attenzioni dei genitori, permettendo a tutti loro di non concentrarsi su un divario ben più pericoloso e consistente.
– CONTINUA –
[1] Boscolo, L., Caille, P., et al. (1983), La terapia sistemica, Editore Astrolabio, Roma, pp. 46-47
Tutti i diritti riservati
Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?
Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.
Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.














