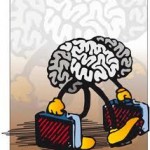Quanto più faccio questo mestiere, quante più persone vedo, mi rendo sempre più conto che molti, di solito coloro che non sono mai stati in terapia e che la reputano ancora una faccenda che riguardi solamente i ‘pazzi’, mi chiedono che tipo di lavoro faccia, cosa succeda dentro la misteriosa stanza di uno psicologo. La curiosità è tanta, ma tanta è anche, purtroppo, l’ignoranza per il tipo di lavoro che uno psicoterapeuta svolge. Mi si chiede spesso perché si va in terapia, perché una persona dovrebbe spendere tempo (e soldi!) per ‘fare due chiacchiere’ con uno sconosciuto. La verità è che spesso queste persone sono tanto incuriosite quanto intimidite dall’idea che ci si possa metter a nudo di fronte ad una persona. Questa considerazione mi ha riportato alla mente un brano che ho letto tempo fa e che si occupa appunto del perché della psicoterapia. Ve lo riporto:
Quanto più faccio questo mestiere, quante più persone vedo, mi rendo sempre più conto che molti, di solito coloro che non sono mai stati in terapia e che la reputano ancora una faccenda che riguardi solamente i ‘pazzi’, mi chiedono che tipo di lavoro faccia, cosa succeda dentro la misteriosa stanza di uno psicologo. La curiosità è tanta, ma tanta è anche, purtroppo, l’ignoranza per il tipo di lavoro che uno psicoterapeuta svolge. Mi si chiede spesso perché si va in terapia, perché una persona dovrebbe spendere tempo (e soldi!) per ‘fare due chiacchiere’ con uno sconosciuto. La verità è che spesso queste persone sono tanto incuriosite quanto intimidite dall’idea che ci si possa metter a nudo di fronte ad una persona. Questa considerazione mi ha riportato alla mente un brano che ho letto tempo fa e che si occupa appunto del perché della psicoterapia. Ve lo riporto:
Ognuno di noi si muove nell’ambito di un sistema di convinzioni, la maggioranza delle quali, pur non essendo apertamente dichiarate, determinano il nostro modo di vivere le nostre relazioni con gli altri. Vorrei dire qualcosa a questo proposito. Prima di tutto niente che valga la pena di imparare può essere insegnato. Tutto deve essere scoperto da ognuno di noi. Questo processo di apprendere ad apprendere, di scoprire la propria epistemologia, il proprio modo di affrontare nuove scoperte, nuovi pensieri, nuove idee, nuove opinioni, richiede una lunga lotta per riuscire a sviluppare sempre meglio ciò che siamo. Tillich ha scritto un libro intitolato Essere è divenire. Questo titolo è stato per me un koan. Per molti anni mi sono chiesto cosa volesse realmente significare, finché all’improvviso tutto è diventato chiaro: agire è un modo per impedirsi di essere, nel senso che se ci si dà abbastanza da fare, non si è obbligati a essere qualcuno. Si può cercare, con sempre maggiore impegno, di diventare qualcosa di diverso da quello che si è: sempre migliori, sempre più potenti, sempre più simile a qualcun altro sempre meno simili a ciò che in passato abbiamo scoperto di essere.
Ma essere è divenire vuol dire che si deve imparare ad essere totalmente ciò che si è. Questo è, ovviamente, un processo pericoloso, perché la struttura sociale tollera solo certi modi di essere persona. Se ci si scopre sadici, bisogna stare attenti ad esserlo al tempo giusto, nel modo giusto con le persone giuste, se non si vuole passare un brutto quarto d’ora. Una delle ragioni per andare in psicoterapia è che, mettendosi in posizione subordinata rispetto ad un estraneo, si può scoprire quel tipo particolare di libertà che rende possibile essere maggiormente se stessi. Uno psicoterapeuta è qualcuno che si può odiare senza provare sensi di colpa. È una di quelle persone con le quali si può essere completamente se stessi, ciò nonostante, venire accettati; o, guardando la cosa da un altro punto di vista, probabilmente un terapeuta può sopportare che un paziente, per circa un’ora alla settimana, sia totalmente se stesso. Osare rivelarsi a qualcuno rende più facile approfondire la conoscenza di se stessi.
Il primo passo consiste nell’imparare ad ascoltarsi: avere il coraggio di aspettare quando non succede nulla, aspettare che qualcosa accada dentro di noi, non fuori di noi, non grazie a qualcun altro diverso da noi. La creatività richiede tempo e solitudine. [1]
Uno dei punti principali di questo brano è che alcune cose devono essere vissute piuttosto che insegnate. Imparare ad essere se stessi secondo me è una di queste: nessun altro, neanche con una serie enorme di titoli e di attestati, può insegnare all’altro come essere se stesso. Solo il viverlo, lo sperimentarlo, può portare ognuno di noi a rintracciare ciò che è l’essenza del suo essere. Questo ribadisce una mia convinzione profonda: in questo campo non ci sono delle autorità in materia, nessuno che ti possa insegnare ad essere. La nostra funzione è, come diceva Socrate, una funzione maieutica: possiamo aiutare a far nascere qualcosa, ma la vita era presente prima del nostro intervento. Tornando al punto, il nostro senso possiamo costruirlo solo attraverso l’esperienza: ma se l’esperienza è censurata socialmente come può avvenirne la costruzione? Questo, secondo Whitaker è il grande significato dell’esperienza della psicoterapia: in essa la persona può sperimentare parti di se che, per motivi sociali o personali, ritiene debbano essere censurate nella sua vita quotidiana. Solo questa sperimentazione può portare ad una consapevolezza prima e ad una valutazione e accettazione (o rifiuto, naturalmente) poi. Quello che con un termine solo chiamiamo crescita. Questo porta alla crescita di se stessi proprio nel momento in cui aumenta la propria consapevolezza. E da questo dobbiamo passare: solo l’esperienza di ciò che siamo intimamente può portarci ad una evoluzione. Il rischio, altrimenti, è quello di continuare a pensare di coltivare e di mostrare solo ciò che riteniamo accettabile o condivisibile. Whitaker dice che il primo passo di questo processo è imparare ad ascoltarsi. Se però ci siamo abituati ad essere sordi nei confronti degli aspetti che di noi non ci piacciono, il pericolo è che queste parti rimangano sempre in ombra e non emergano. Questo è ciò che avviene all’interno della psicoterapia: in uno spazio protetto la persona può permettersi di sperimentare parti considerate inaccettabili. La condivisione senza giudizio porta spesso a rivalutare queste parti di se stessi e a pensare di rimetterle in gioco nella vita di tutti i giorni. E non è cosa da poco autorizzarsi a condividere parti di noi che fingiamo non esistano. Credo sia questo il sostegno che siamo chiamati a dare all’interno della professione.
Che ne pensate?
A presto…
Fabrizio Boninu
[1] Whitaker, C. (1989), Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia, Astrolabio, Roma, pag. 69
Tutti i diritti riservati

 Se vogliamo la condizione di subalternità o di non autonomia del paziente potrebbe essere rafforzata proprio perché avviene in un contesto al quale si è rivolto per essere aiutato e nemmeno in questa occasione, per il paziente molto importante, si sentirà di essere stato in grado di fronteggiare autonomamente la propria vita. Il terapeuta deve essere consapevole che questa possibilità è così insidiosa e dovrebbe avere chiari i rischi che si corrono nel credere al proprio ruolo di guru.
Se vogliamo la condizione di subalternità o di non autonomia del paziente potrebbe essere rafforzata proprio perché avviene in un contesto al quale si è rivolto per essere aiutato e nemmeno in questa occasione, per il paziente molto importante, si sentirà di essere stato in grado di fronteggiare autonomamente la propria vita. Il terapeuta deve essere consapevole che questa possibilità è così insidiosa e dovrebbe avere chiari i rischi che si corrono nel credere al proprio ruolo di guru.