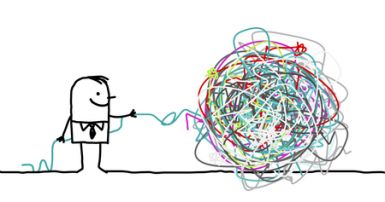Il tema che affrontiamo in questo post è un tema duro, complesso e disturbante. Parliamo di pedofilia e lo facciamo con una persona che se ne occupa da parecchi anni e in diversi contesti. Una di quelle persone preziose che, anziché ritrarsi inorridito da questo baratro, ha deciso di guardarci dentro e a fondo, cercando di illuminarne gli anfratti, di chiedere e chiedersi il perché, di portare alla luce tutti gli elementi che avvicinano questo baratro a noi e alle nostre storie. Una persona che ha cercato di svegliare le coscienze intorpidite dalla paura e dall’orrore, coscienze che spesso si voltano, con le pericolose conseguenze che ne discendono, pur di non vedere una realtà spaventosa. Sto parlando di Massimiliano Frassi, autore di diversi bestseller sul tema della pedofilia, organizzatore con l’associazione Prometeo del coordinamento nazionale delle vittime di abuso. Ci racconterà meglio lui la sua storia e il suo percorso. Per quanto riguarda la mia storia, mi sto occupando sempre più spesso di questo tema, inserito all’interno della distorsione adultocentrica della nostra società e, in questo mio percorso di conoscenza e approfondimento, ho avuto la fortuna di incontrare Massimiliano ad un convegno organizzato dalla fondazione Domus de Luna (clicca sul nome per visualizzare la pagina della fondazione) a Cagliari.
Scomodo, emozionante, pungente, disturbante, sconvolgente, sono solo alcuni degli aggettivi che mi vengono in mente per descrivere il convegno. E, forse, adatti per descrivere Massimiliano stesso.
Parlare di materie così complesse mette in difficoltà, costringe a confrontarci con una realtà impossibile solo da immaginare. Una realtà che, invece, esiste e che, su questa nostra difficoltà, prospera e cresce. Una realtà misconosciuta, dove giocano anche stereotipi e pregiudizi che, con l’aiuto di Massimiliano, cercheremo di vagliare.
Ciao Massimiliano, benvenuto e grazie per aver accettato l’invito e parlare con me di un tema che ti/ci sta tanto a cuore. Dopo la mia breve presentazione, vogliamo darne una più approfondita per chi non conoscesse il tuo lavoro: chi sei e di cosa ti occupi?
Sono il responsabile di Prometeo Onlus, una associazione, da me fondata circa 20 anni fa e tra le più attive, in Italia, nel campo della lotta alla pedofilia. Da una parte siamo operativi e diamo assistenza e tutela alle vittime, molte delle quali adulte che solo oggi trovano la forza e la possibilità di parlare e chiedere aiuto e dall’altra parte facciamo formazione e sensibilizzazione affinché l’omertà che protegge chi abusa sia definitivamente annientata.
La prima curiosità è: come sei arrivato ad occuparti di un tema così forte come la pedofilia?
Non per aver subito abusi io stesso, semmai per poter dare agli altri la stessa infanzia che ho avuto io. Professionalmente parlando è stata parte di un percorso, partito con una scelta di vita che mi ha portato ad operare prima come operatore di strada, che si occupava di emarginazione grave e poi di minori, specializzandomi e fondando la Prometeo.
Che realtà è la pedofilia oggi?
La realtà di sempre. Che vede un abusante e buona parte della società, abilmente impegnati a zittire un bambino. Per potergli nuocere.
All’interno del tuo intervento, mi ha colpito come tu sia riuscito a mettere in discussione alcuni stereotipi ben radicati. Il primo è che, nell’immaginario collettivo, la pedofilia sia un fenomeno prettamente maschile. É proprio così?
Purtroppo da alcuni anni a questa parte assistiamo ad un fiorire di una pedofilia al femminile. Numericamente minoritaria, con percentuali molto basse, ma pesanti “qualitativamente”. Perché quando è la mamma ad abusare, ad es., è chiaro che le ferite saranno ancora più profonde.
Altro stereotipo: gli abusanti sono spesso stati abusati a loro volta. Possiamo confermarlo?
Sì, ma non lo dico io, anche se 20 anni di esperienza mi danno il potere di poterlo gridare forte. Lo dicono tutti i trattati scientifici che hanno davvero studiato questa assurda equazione. Creata dai pedofili per, in qualche modo, difendersi, tutelarsi e nuovamente infangare le vittime. Poi può capitare che su un numero elevatissimo di vittime ci sia chi diventa pedofilo, ma se c’è è davvero un numero bassissimo che non rende tale equazione reale. Chi lo sostiene dimostra di non aver mai lavorato nel campo dell’abuso ma ancora prima, dimostra di non aver rispetto delle vere vittime.
Sapessi quante donne seguo che hanno paura di rimanere incinta perché “magari poi diventano pedofile e fanno provare al proprio figlio quanto hanno provato loro” e questa mala educazione, gliel’ha inculcata chi doveva guarirle. Non renderle vittime a vita.
Ancora: il pedofilo è un mostro, una sorta di orco facilmente identificabile. Cosa c’è di vero?
Nulla. È ovviamente mostruoso l’atto che compie. Ma se cerchiamo l’orco, così come pensiamo lo sia, non lo vedremo mai nel bravo vicino di casa, nello zio affettuoso, nel maestro severo ma presente, nel parroco pacioccone.
Ho letto il tuo lavoro ‘Il libro nero della pedofilia‘ e le cifre sono spaventose. Credi sia un fenomeno in aumento o stia semplicemente affiorando sempre più in superficie?
Forse entrambe le cose.
Oggi se ne parla poco ma sicuramente molto più di quando iniziammo anche solo 20 anni fa. Poi c’è internet, con il suo lato oscuro e la possibilità di avere accesso a materiale che farebbe uscire di testa qualsiasi essere umano, ma che a loro dà piacere. Ed a lungo andare si stuferanno della “sola” foto e passeranno al contatto diretto. Poi ancora oggi c’è la possibilità di fare viaggi dall’altro capo del mondo, con spese irrisorie rispetto ad una volta e comunque alla portata di tutti, che favoriscono i turisti sessuali, cacciatori di bambine e bambini coetanei dei figli che lasciano a casa.
Sono tutte varianti che portano allo stesso punto: il progresso di questa civiltà ha paradossalmente portato ad una regressione di parte della stessa. In parole spicce, se da una parte siamo andati sulla Luna, dall’altra siamo tornati a Jurassic Park.
In questo giocano un ruolo enorme le nuove tecnologie: social network, smartphone rendono la pedofilia più ‘facile’ e ‘fruibile’?
Sì, purtroppo sì. Molto banalmente: pensiamo a cosa voleva dire per un pedofilo dover far sviluppare un rullino con delle immagini di abusi da lui prodotte. E pensiamo oggi con il più piccolo smartphone cosa non si può fare.
Quali sono le aree geografiche più interessate al fenomeno?
È un fenomeno trasversale. Che tocca tutte le sfere della società. Non certo solo le aree più povere. Poi di sicuro se dobbiamo fare una analisi “geografica”, posso dire che ci sono aree dove il retaggio culturale ancora favorisce il silenzio. L’omertà. Ma questo vale nel paesino del bresciano, come in quello del cagliaritano.
La pedofilia è una realtà percepita come distante dalla nostra vita quotidiana. Queste sono cose che succedono agli altri, lontani da noi. Noi, e i nostri figli, siamo ‘al sicuro’. E funziona fino a quando un caso cruento di cronaca nera scuote le coscienze. Penso al caso di Yara Gambirasio. O del piccolo Tommaso Onofri. Come possiamo stare attenti a quello che succede intorno a noi?
Questo non è un paese per bambini. Lo grido, disperatamente, da tempo. Basandomi su fatti concreti. Avrei preferito che i fatti mi smentissero. Che i pazzi fossimo noi. Ma purtroppo così non è stato. E la piccola Yara o il nostro angioletto Tommaso, sono solo la punta dell’iceberg. Bimbi strappati dal loro mondo. E sottratti al nostro futuro. Sarebbero diventati dei grandi adulti, in grado di fare grandi cose. Ma qualcuno ha scelto che così non fosse e l’ha deciso con la violenza.
Pensare a loro come fossero figli nostri, forse la risposta sta proprio lì….loro ovviamente in rappresentanza di Salvo, Roberto, Susanna, Lucia, Silvia, Carolina, Alex, Giovanni, Massimo, Rosaria, Andrea, e via dicendo per un elenco di bambini numericamente elevatissimo. Bimbi non finiti per fortuna sul tavolo di un obitorio, ma morti dentro. Fino a quando non troveranno chi riaccenderà in loro la speranza e la voglia di vivere.
C’è, tra i diversi casi che ha seguito personalmente, un caso che ti ha coinvolto più degli altri?
No. Ognuno ha la sua importanza. Ognuno il suo dolore. Poi sì, di sicuro c’è quello che ti resta più dentro, per vari motivi, ma ripeto sono tutti uguali e tutti meritano lo stesso posto e lo stesso rispetto.
La pedofilia spaventa e atterrisce perché è un fenomeno di proporzioni enormi. Nel nostro quotidiano, cosa possiamo fare noi?
Informarci. Ed indignarci. Non chiediamo molto, non credi? Peraltro lo facciamo per mille cose futili. Farlo per qualcosa di serio, non sarebbe male. E sarebbe ora!
C’è qualcosa che non ti ho chiesto che mi vorresti dire?
Sì, se c’è vita, un futuro dopo l’abuso. E la risposta è: “certo che c’è. Si può e si deve tornare a vivere. E quando accade, ed accade sempre, è meraviglioso!”.
Parola di Massimiliano Frassi.
Ringrazio di cuore Massimiliano per essersi prestato alle mie domande. Il tema è vasto e mi riprometto di tornarci. Chi fosse interessato può visitare il blog di Massimiliano: potete cliccare sul link L’INFERNO DEGLI ANGELI e verrete reindirizzati al sito. Consiglio vivamente anche la lettura dei suoi testi (trovate tutta la bibliografia sul sito L’inferno degli angeli), tra tutti il già citato Il libro nero della pedofilia con prefazione di Alessia Sinatra ed edito da La Zisa.
Come sempre chi volesse/potesse condividere la sua esperienza può farlo contattandomi per mail (fabrizioboninu@gmail.com) oppure per telefono (3920008369).
Che ne pensate?
A presto…
Fabrizio Boninu
Tutti i diritti riservati

Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?
Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.
Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.
 Adulti invidiosi e mal disposti, li definisce l’autore. Invidiosi di cosa? Cosa può invidiare l’adulto a questi giovani perennemente annoiati e in crisi con la propria vita? Le cose che possono suscitare invidia sono diverse: la vitalità, il tempo, le possibilità, le occasioni, le infinite prospettive che si trova davanti, le opportunità, le esperienze da fare. Non che questi aspetti non possano far parte del mondo adulto, ma spesso molti, una volta cresciuti, non vedono queste possibilità in un vita ormai ordinata, spesso ordinaria, una vita che ha assunto una piega che non lascia intravedere grandi possibili novità. Questo sentire, non ammissibile e non confessabile, spesso neanche cosciente, induce una particolare severità nel giudicare la vita dei ragazzi, severità attraverso la quale non percepiamo l’altro lato della medaglia, il dolore, lo sconforto e la paura che suscita diventare grandi. Se riuscissimo a ricontattare l’adolescente che siamo stati, forse ci tornerebbe alla mente il miscuglio di eccitazione e terrore, di paura e sfida, di sicurezza e fragilità che l’adolescenza comporta. Gli esiti imprevedibili di questa miscela sono ben più spaventosi di quanto un adulto riesca a percepire o ricordare. Anche la noia in questa prospettiva, assume contorni nuovi e stupefacenti, contorni che l’adulto stenta a riconoscere:
Adulti invidiosi e mal disposti, li definisce l’autore. Invidiosi di cosa? Cosa può invidiare l’adulto a questi giovani perennemente annoiati e in crisi con la propria vita? Le cose che possono suscitare invidia sono diverse: la vitalità, il tempo, le possibilità, le occasioni, le infinite prospettive che si trova davanti, le opportunità, le esperienze da fare. Non che questi aspetti non possano far parte del mondo adulto, ma spesso molti, una volta cresciuti, non vedono queste possibilità in un vita ormai ordinata, spesso ordinaria, una vita che ha assunto una piega che non lascia intravedere grandi possibili novità. Questo sentire, non ammissibile e non confessabile, spesso neanche cosciente, induce una particolare severità nel giudicare la vita dei ragazzi, severità attraverso la quale non percepiamo l’altro lato della medaglia, il dolore, lo sconforto e la paura che suscita diventare grandi. Se riuscissimo a ricontattare l’adolescente che siamo stati, forse ci tornerebbe alla mente il miscuglio di eccitazione e terrore, di paura e sfida, di sicurezza e fragilità che l’adolescenza comporta. Gli esiti imprevedibili di questa miscela sono ben più spaventosi di quanto un adulto riesca a percepire o ricordare. Anche la noia in questa prospettiva, assume contorni nuovi e stupefacenti, contorni che l’adulto stenta a riconoscere: