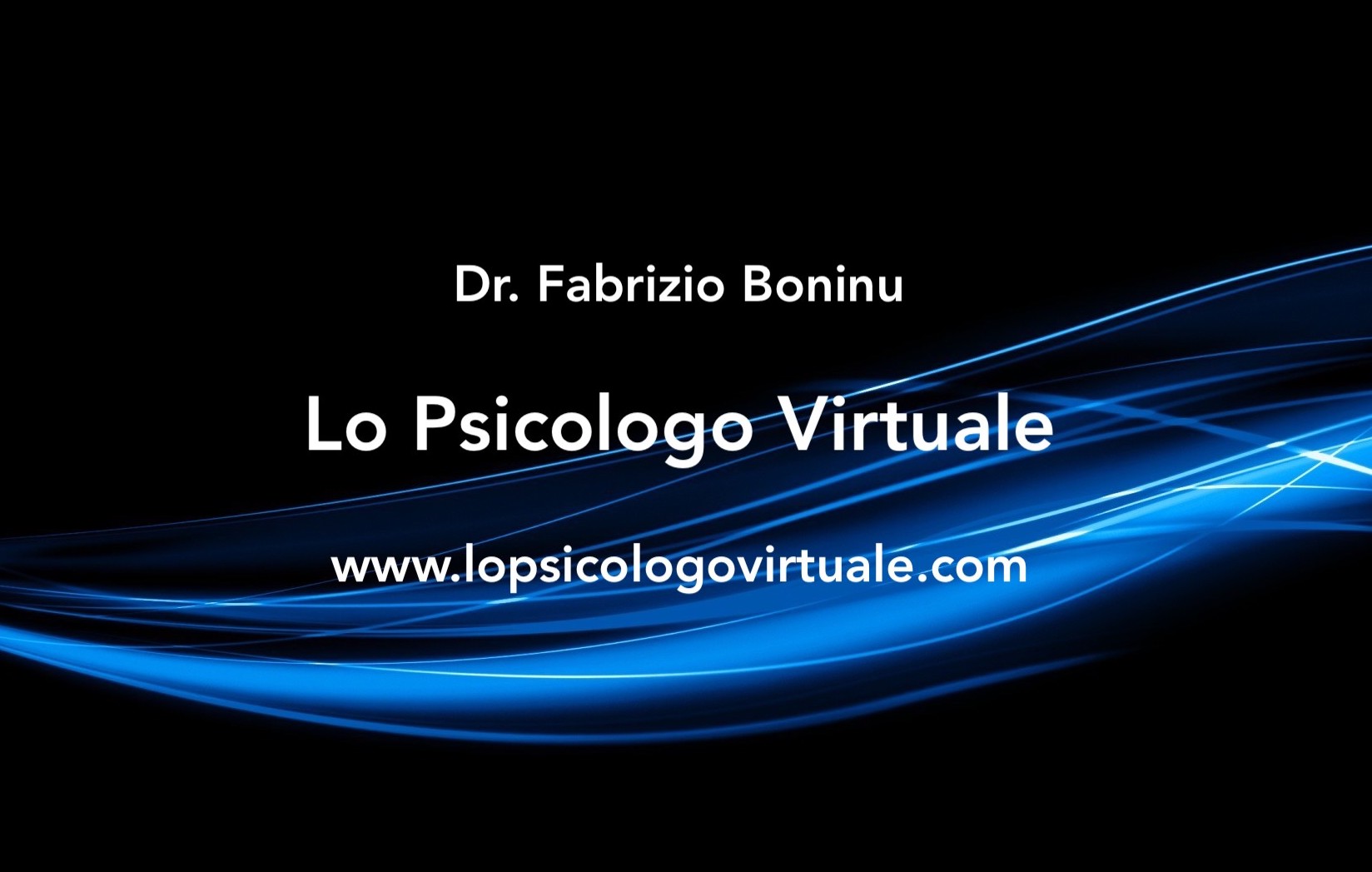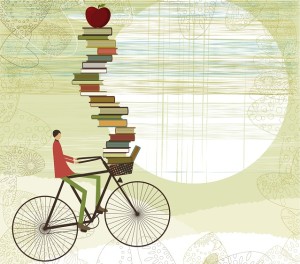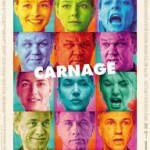Anche quest’anno, come ogni anno ormai, le feste di Natale hanno portato, come una piaga sempiterna, i circhi nella nostra città. Anche quest’anno si sono sprecate le polemiche circa la necessità di autorizzare e dare spazio ad uno spettacolo che definire vergognoso è assolutamente eufemistico. Non mi si venga a dire che quella di assistere e portare in scena questo tipo di spettacoli fa parte della nostra cultura, perché potrei rispondere che anche le uccisioni in piazza erano delle messe in scena che facevano parte della nostra cultura, ma spero conveniate con me che non ne debbano più far parte. Sembra, invece, che continuiamo ad essere particolarmente indulgenti nei confronti di questa tradizione e ogni anno le polemiche si riaccendono.
Anche quest’anno, come ogni anno ormai, le feste di Natale hanno portato, come una piaga sempiterna, i circhi nella nostra città. Anche quest’anno si sono sprecate le polemiche circa la necessità di autorizzare e dare spazio ad uno spettacolo che definire vergognoso è assolutamente eufemistico. Non mi si venga a dire che quella di assistere e portare in scena questo tipo di spettacoli fa parte della nostra cultura, perché potrei rispondere che anche le uccisioni in piazza erano delle messe in scena che facevano parte della nostra cultura, ma spero conveniate con me che non ne debbano più far parte. Sembra, invece, che continuiamo ad essere particolarmente indulgenti nei confronti di questa tradizione e ogni anno le polemiche si riaccendono.
Come ci ricorda la LAV, in Italia ci sono ancora 2000 animali prigionieri: la maggior parte di loro, come tigri e leoni, sono nati in cattività, mentre altri sono stati importati, spesso illegalmente. (…) un leone o una tigre del circo vivono in uno spazio di 3 metri quadri. La tortura è reale, se consideri le dimensioni medie di un circo e gli animali ospitati. La realtà dell’addestramento si basa sulla violenza, fisica e psicologica. Sulla paura del dolore fisico e sulla privazione del cibo. Il resto lo fanno i bastoni, le percosse, a volte anche i pungoli elettrici. In gabbia gli animali soffrono, anche se i circensi dicono di no. I segnali del loro malessere sono evidenti, basta solo saperli cogliere: in cattività sviluppano atteggiamenti stereotipati, come dondolarsi continuamente, o girare su sé stessi. (Fonte www.lav.it)
Dato il mestiere che faccio, uno degli aspetti che più mi colpisce è come alcuni adulti si ostinino a portare i bambini al circo. Mettetevi un attimo nei panni di un bambino: arriva in un posto magico, un posto che non c’è sempre. Che arriva solo in alcuni periodi dell’anno. Vede animali che non fanno parte della sua quotidianità fare numeri strani, obbedire a comando all’uomo che si relaziona con loro. Vede come spesso l’obbedienza sia ottenuta con urla o con colpi di frusta. Succedono delle cose che, nello stupore del bambino, non tornano. Perché un animale grosso come un elefante dovrebbe piegarsi per farsi salire addosso un essere piccolo come un uomo? Non dovrebbe comandare lui, essendo più grosso? Sa che questo succede nella vita di tutti i giorni: il più grande sa cosa sia giusto fare. In questo mondo magico tutto è rovesciato. Non comandano i più grandi e, per ubbidire, si utilizza la forza.
L’ambiguità viene accentuata dal fatto che il clima generale è un clima di festa e gli adulti attorno a lui lo autorizzano a ‘godersi’ lo spettacolo. La nota sorda rimane e, tenendo a mente che ci troviamo nei panni di un bambino, non abbiamo gli strumenti cognitivi per comprendere questa situazione. Ma qualcuno degli adulti che lo circondano, che questi strumenti cognitivi dovrebbero, invece, aver maturato, si è mai domandato che tipo di messaggio sta dando al bambino facendolo assistere ad una tortura? Il messaggio che passa è, a mio avviso, di una violenza enorme: stiamo chiedendo loro di trovare divertente andare a vedere un essere che, per fare quello che sta facendo, è stato privato della sua libertà, è stato torturato, e viene costretto con la paura ad effettuare cose che la sua natura non gli imporrebbe di fare (come stare in equilibrio su una pedana). Stiamo facendo vedere ed insegnando loro ad infischiarsene della sofferenza di qualche essere vivente (sono ‘solo’ animali, no?), di non curarsi del suo dolore perché il MIO divertimento viene prima di tutto. Apprenderà così che il suo benessere può essere anteposto alla vita di altri e alle sofferenze che gli si devono infliggere perché si diverta.
Come possiamo pretendere che i bambini siano empatici nei confronti delle sofferenze altrui se li abituiamo ad essere sordi a quello che vedono o a considerarlo divertimento? Questa riflessione è rivolta particolarmente a tutti quegli adulti che si scagliano, invece, così violentemente contro videogiochi considerati crudeli o sanguinari, e che invece sono così inspiegabilmente comprensivi nei confronti di uno spettacolo altrettanto crudele.
Non credo ci sia nulla di educativo o di divertente in tutto questo. E non penso sia saggio continuare a ripetere come questo serva anche ad altro, come a far vedere animali esotici ad un bambino. Sarebbe meglio portarli in un parco o fargli vedere un documentario, sempre che non si possa fare un viaggio. Sarebbe meglio spiegare loro l’impossibilità di fare vivere questi animali da noi se non snaturando le loro stesse caratteristiche. I genitori sanno che la naturale curiosità dei bimbi li porta a voler essere in prima fila nei circhi, ma l’ambigua malinconia di quello che vedono non è costruttiva. In nulla. Sarebbe uno spettacolo perfetto solo se il nostro fine fosse desensibilizzarli.
Mi fa ben sperare che i dati diffusi dimostrino una inversione di tendenza rispetto agli accessi nei circhi: il numero di esibizioni è calato in un anno (2012) da 17.404 a 15.603 e gli ingressi, idem, da 1.135.037 a 1.121.758. Mi sembra che rimangano sempre troppe le persone che alimentano questo rimasuglio di altre epoche e sempre troppi i bambini che hanno la sventura di assistere, senza strumenti per comprendere e anzi rinforzati dall’idea che assistano ad una cosa divertente, ad uno spettacolo indegno.
Personalmente tornerò sotto il tendone di un circo quando lo spettacolo sarà libero da animali, quando vedrò artisti che hanno scelto liberamente di dedicare la propria vita allo spettacolo che interpretano. Fino ad allora non finanzierò più questi commercianti di finto divertimento e di vera sofferenza.
A presto…