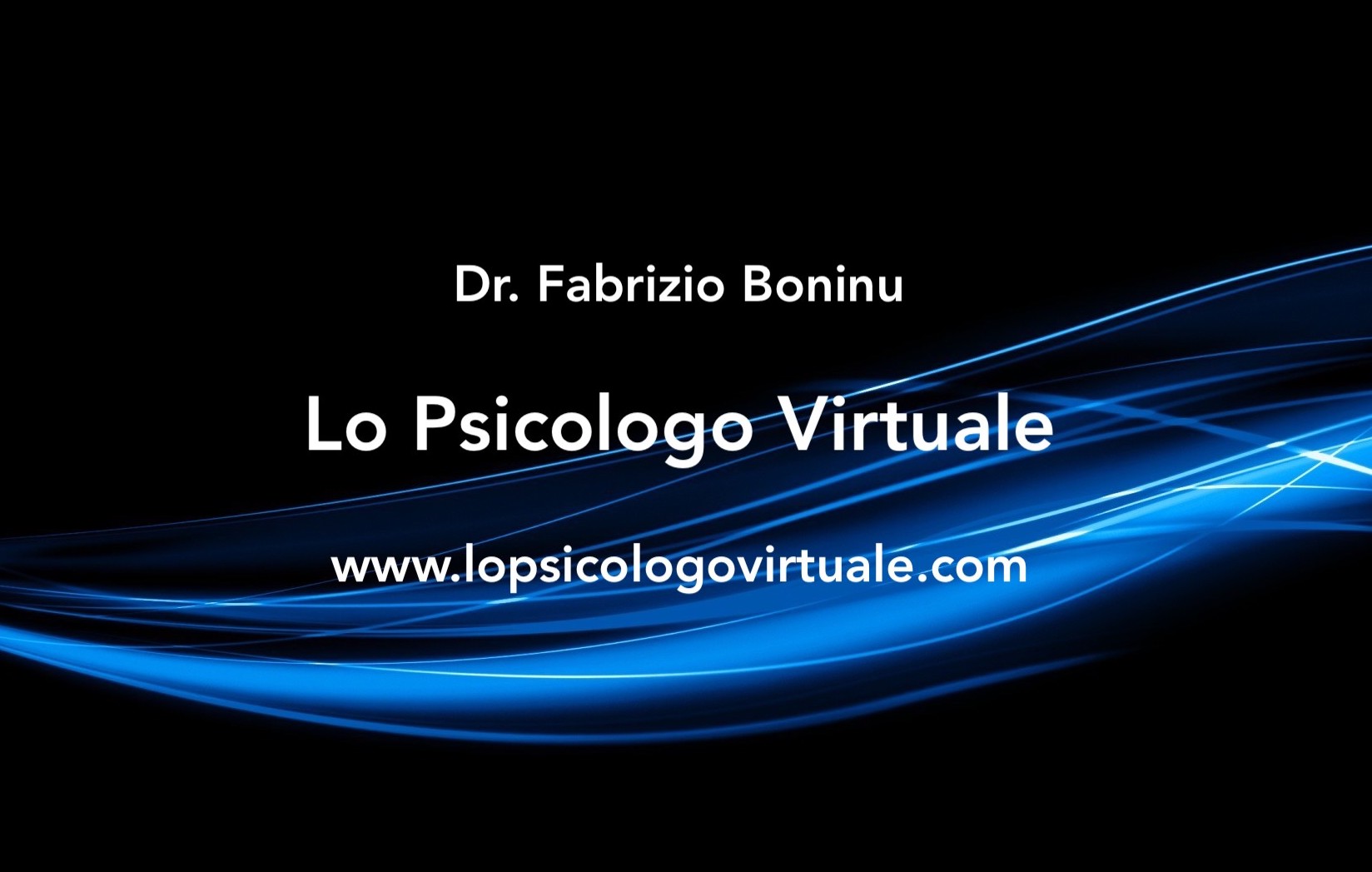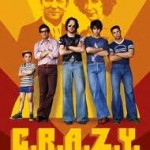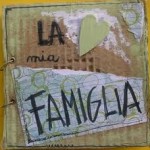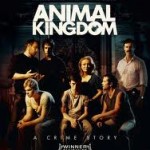Il post di oggi è dedicato all’analisi di una figura purtroppo diffusa in terapia: quello del terapeuta riparatore. Il terapeuta riparatore è il terapeuta che, dimenticandosi la necessaria distanza dalla vita dell’individuo con cui si trova a lavorare, si schiera per una soluzione e, forte della sua posizione all’interno della terapia stessa, spinge affinché il paziente attui la soluzione da lui suggerita. Questo tipo di situazione è molto più frequente di quanto non sembri, soprattutto per situazioni che richiederebbe una maggiore apertura mentale e una maggiore capacità collaborativa del terapeuta come per esempio, quelle terapie per le quali la persona, sentendo molto forte e toccante vivere la sua omosessualità, chiede al terapeuta di guarirlo. L’aspetto più pericoloso avviene quando il terapeuta prende per buona e cerca di soddisfare questa richiesta. Questo tipo di situazioni sono, secondo me esecrabili per due ordini di motivi: innanzitutto la terapia non si svolge correttamente, dato il peso che le convinzioni, sociali, morali o religiose del terapeuta stesso, in una parola le sue convinzioni personali, vengono adoperate ed utilizzate per stabilire arbitrariamente ciò che è giusto oppure no per la vita di un altro individuo; in secondo luogo ratifica e prosegue, in una vera e propria spirale auto perpetuante, lo stereotipo per cui stili di vita bollati a lungo come non ‘normali’ siano vere e proprie malattie, quando l’omosessualità da ormai 39 anni, è stata derubricata definitivamente anche dai manuali diagnostici che noi professionisti utilizziamo nella nostra pratica clinica.
Il post di oggi è dedicato all’analisi di una figura purtroppo diffusa in terapia: quello del terapeuta riparatore. Il terapeuta riparatore è il terapeuta che, dimenticandosi la necessaria distanza dalla vita dell’individuo con cui si trova a lavorare, si schiera per una soluzione e, forte della sua posizione all’interno della terapia stessa, spinge affinché il paziente attui la soluzione da lui suggerita. Questo tipo di situazione è molto più frequente di quanto non sembri, soprattutto per situazioni che richiederebbe una maggiore apertura mentale e una maggiore capacità collaborativa del terapeuta come per esempio, quelle terapie per le quali la persona, sentendo molto forte e toccante vivere la sua omosessualità, chiede al terapeuta di guarirlo. L’aspetto più pericoloso avviene quando il terapeuta prende per buona e cerca di soddisfare questa richiesta. Questo tipo di situazioni sono, secondo me esecrabili per due ordini di motivi: innanzitutto la terapia non si svolge correttamente, dato il peso che le convinzioni, sociali, morali o religiose del terapeuta stesso, in una parola le sue convinzioni personali, vengono adoperate ed utilizzate per stabilire arbitrariamente ciò che è giusto oppure no per la vita di un altro individuo; in secondo luogo ratifica e prosegue, in una vera e propria spirale auto perpetuante, lo stereotipo per cui stili di vita bollati a lungo come non ‘normali’ siano vere e proprie malattie, quando l’omosessualità da ormai 39 anni, è stata derubricata definitivamente anche dai manuali diagnostici che noi professionisti utilizziamo nella nostra pratica clinica.
Eppure, nonostante queste premesse, è possibile trovare professionisti che pensano sia possibile curare quella che non è una malattia, assecondando più i desideri reconditi del terapeuta piuttosto che riuscendo ad accogliere quelle che sono le istanza più intime di accettazione e di rispetto che il paziente va cercando, e anzi, disconoscendole e disconfermandole ancora una volta. Vi riporto, a questo proposito, un brano tratto da un testo che affronta molto bene il punto di vista del quale stiamo parlando:
Dopo la derubricazione dell’omosessualità come diagnosi clinica, il DSM-IV del 1974 (il manuale diagnostico usato per fare le diagnosi) prevedeva la nuova categoria dell'”omosessualità egodistonica”: il disagio e la sofferenza rispetto al proprio orientamento sessuale venivano considerati un disturbo psichiatrico. Questa categoria clinica venne in seguito rimossa nel 1987, quando si comprese che l’egodistonia può far parte del percorso evolutivo di un individuo omosessuale in un contesto eterosessista. Proprio sul concetto di egodistonia si soffermano i terapeuti riparativi. Questi permangono impermeabili alle numerose ricerche e dichiarazioni delle associazioni dei professionisti della salute mentale. Le cosiddette ‘terapie di conversione’ sono residui del paradigma patologico (…), secondo cui gli ‘omosessuali non gay’, coloro i quali non riescono a conciliare l’orientamento sessuale con il sistema di valori, possono cambiare il loro orientamento sessuale. E’ il vecchio concetto di egodistonia rispolverato, insostenibile alla luce delle oramai assodate acquisizioni scientifiche e deontologicamente impraticabile a fronte dei pesanti effetti sulla salute mentale dei soggetti che vi si rivolgono. In questo tipo di trattamento direttivo-suggestivo il terapeuta rinuncia alla sua posizione di neutralità, di chi interroga e si interroga insieme al paziente, diventando mero esecutore della richiesta e propugnatore di norme morali e religiose.” [1]
Credo che il massimo che possiamo dare alle persone con le quali abbiamo la fortuna di lavorare, sia accoglierle e rispettarle. Comprenderle più che cambiarle. Ascoltarle più che curarle. Non è semplicemente una proposta di buon senso, visto che anche deontologicamente non potremmo imporci, ne imporre la nostra volontà o le nostre convinzioni sui nostri pazienti. Può essere vero che ci siano temi coi quali può non piacere lavorare ma, in questo caso, sta alla professionalità del terapeuta riconoscerlo ed esplicitare al paziente stesso la sua inidoneità per lavorare su quella tematica. Chiunque voglia curare ciò che non è in grado di rispettare non è semplicemente in grado di fare questo mestiere, perché è la prima persona a non avere conoscenza di se stessa.
E se una persona non è in grado di essere chiara con se stessa come può aiutarne un’altra?
Che ne pensate?
A presto…
[1] Chiari, C., Borghi, L. (2009), Psicologia dell’omosessualità, Carocci, Roma, pp. 173-174