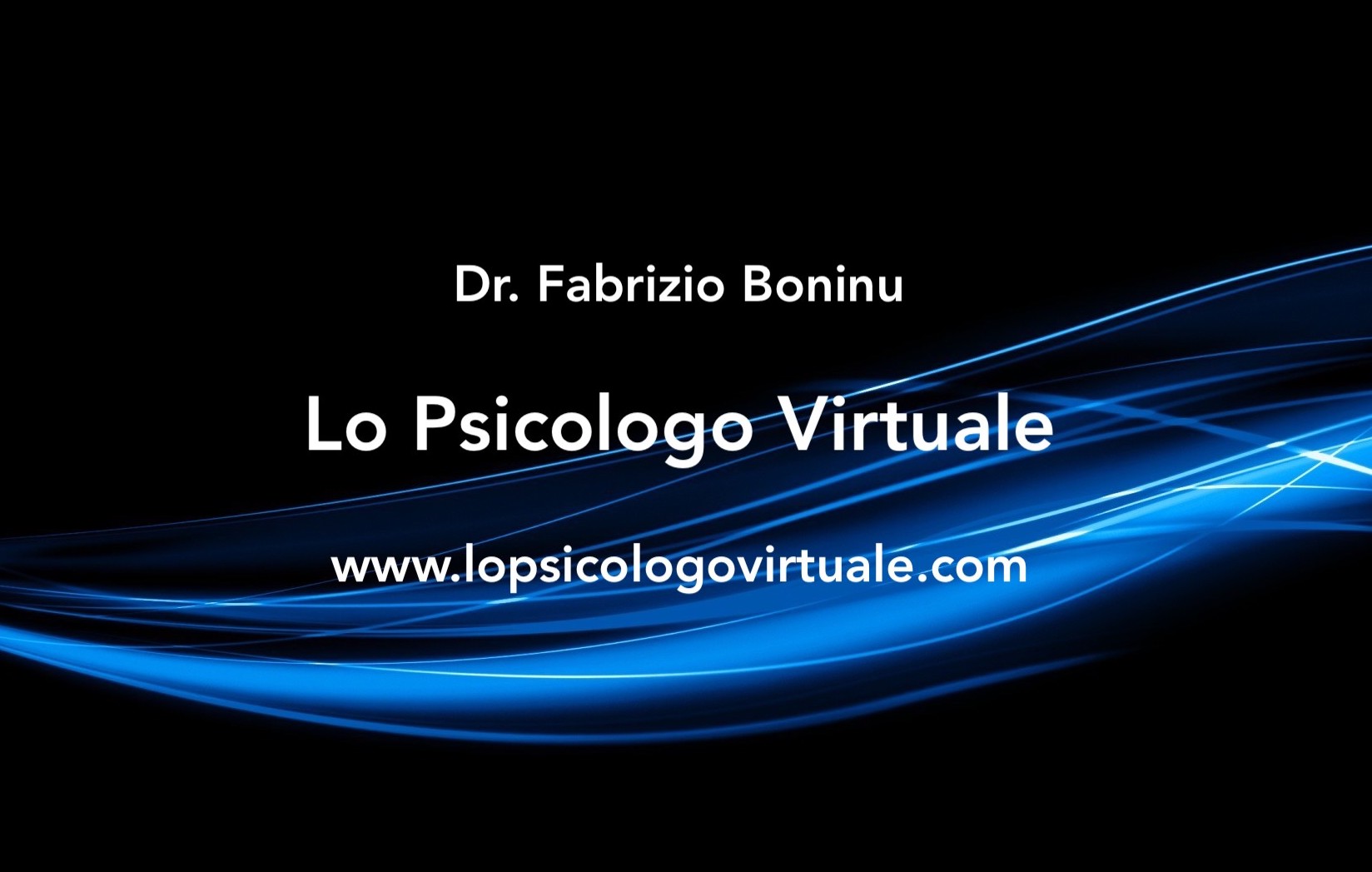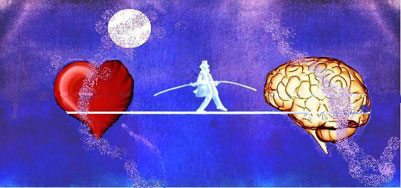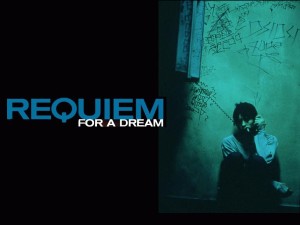Quando accadono fatti di cronaca nera che coinvolgono bambini o adolescenti, vengono citate, tra le cause di quello che succede, la mancanza di figure educative che possano in qualche modo porre freno alla deriva apparentemente senza fine di questi fatti terribili. Chi è un educatore oggi? Il termine è veramente molto vago e potrebbe delineare tutti coloro che si occupano a vario livello di persone che abbiano bisogno di una guida. Sicuramente è un educatore il genitore, è un educatore l’insegnante, è un educatore l’allenatore sportivo.
Secondo il dizionario Treccani, l’educatore è colui il quale ‘educa, e soprattutto chi per vocazione o per professione compie l’ufficio di educare i giovani’. Punto principale di questa definizione è il termine educare: l’etimologia del termine deriva dal latino e-ducere, letteralmente condurre fuori, ma anche trarre da e sottolinea il lavoro maieutico di portare fuori l’adulto dal ragazzo, di riuscire ad insegnargli a come diventare grande. Se non ci sono dubbi sul fatto che gli adulti abbiano questo immenso potere, ce ne sono invece tanti sul come si fa l’educatore.
Gli insegnanti o i formatori continuano a fare interventi caratterizzati dalla tendenza a spiegare, a moraleggiare, puntando esclusivamente sugli argomenti logici o sugli sforzi informativi. Siamo portati con i soggetti in età evolutiva ad esortare e a fare la predica. Ci convinciamo che il fulcro della nostra missione sia consigliare, offrire suggerimenti o soluzioni. Come educatori tendiamo sempre prima di tutto ad insegnare, argomentare, persuadere; per allontanare la complessità e la sofferenza possiamo rassicurare, simpatizzare, consolare, sostenere; quando il disagio in noi aumenta allora attendiamo a sottrarci, cambiare argomento, scherzare, distrarre; infine quando gli allievi non corrispondono più alle nostre aspettative allora etichettiamo, ridicolizziamo, umiliamo, giudichiamo, critichiamo, biasimiamo, diamo ordini, minacciamo… Magari in nome di una cultura democratica.
Siamo insomma disposti a fare di tutto per fuggire dal compito arduo dell’ascolto delle emozioni e delle storie dei nostri interlocutori. I bambini, i ragazzi che hanno difficoltà ad accettare l’altro, così come quelli che vivono l’esperienza di essere considerati diversi, sono soggetti che hanno massimamente bisogno di un ascolto attivo. Dietro la rabbia, l’arroganza, il disprezzo, l’onnipotenza che sottendono i comportamenti razzisti violenti, ci sono a ben vedere sentimenti che tendono ad essere mascherati, negati e trasformati nel loro contrario: la solitudine che spinge alla coesione compensativa del gruppo violento, l’impotenza che si tramuta in arroganza onnipotente, la paura che diventa il coraggio nei confronti dei più deboli magari perché provenienti da altrove. E ascoltare, per un educatore, non significa certo accettare schemi violenti a manipolatori, bensì favorire una circolarità dell’ascolto, promuovere nel gruppo classe la possibilità di lasciare esprimere e legittimare sentimenti, punti di vista, storie di vita che hanno una loro radicale originalità. [1]
Il punto che reputo importante del passo che vi ho riportato è la difficoltà che spesso gli adulti hanno nel rapportarsi con la realtà emotiva dell’altro. Presi come siamo dal voler imporre, con difficoltà riusciamo (se ci riusciamo!) a fermarci ad ascoltare la realtà dei ragazzi, condividerne la visione del mondo, comprendere le scelte, supportarne le paure. Il confronto coi ragazzi, e parlo per esperienza diretta, richiede, prima di entrare in contatto con l’altro, l’entrare in contatto profondo con se stessi, con le proprie paure, con la propria visione del mondo. Ed è un terreno nel quale non ci piace avventurarci, specie se diamo per scontato che diventando adulti abbiamo anche acquisito il potere di non dover più confrontarci con parti di noi che non ci piacciono e che non hanno necessità di essere rinvangate.
Il confronto coi ragazzi invece ci porta spesso su quel terreno e faremmo di tutto per evitarlo. Più evitiamo questo confronto, più ci irrigidiamo nei confronti del bambino/ragazzo, più questo sente la nostra distanza rendendo questo un circolo vizioso che si alimenta di continuo, diventando problematico spesso durante l’adolescenza, età nella quale tutte le dinamiche appaiono particolarmente amplificate. Come si spezza il cerchio? Con l’ascolto, un ascolto attivo, un ascolto partecipe, un ascolto interessato, che faccia sentire l’altro coinvolto in quello che ci riguarda. Un ascolto che parta dal nostro stesso ascolto, dalla conoscenza, dalla comprensione e dall’accettazione di quello che noi sentiamo e proviamo. Solo in questo modo potremmo metterci a disposizione per l’altro. Non è sicuramente una cosa facile: dopotutto anche a noi è stato insegnato di crescere mettendo da parte quanto più possibile la nostra realtà emotiva.
Solo recuperando quello che ci appartiene possiamo utilizzarlo come ponte per comunicare con chi, in fondo, vuole essere aiutato a tirare fuori e a capire come maneggiare quello che sta faticosamente iniziando a sentire.
Che ne pensate?
A presto…
[1] Foti, C. (2012), La mente abbraccia il cuore, Edizioni GruppoAbele, Torino, pag. 185
Tutti i diritti riservati