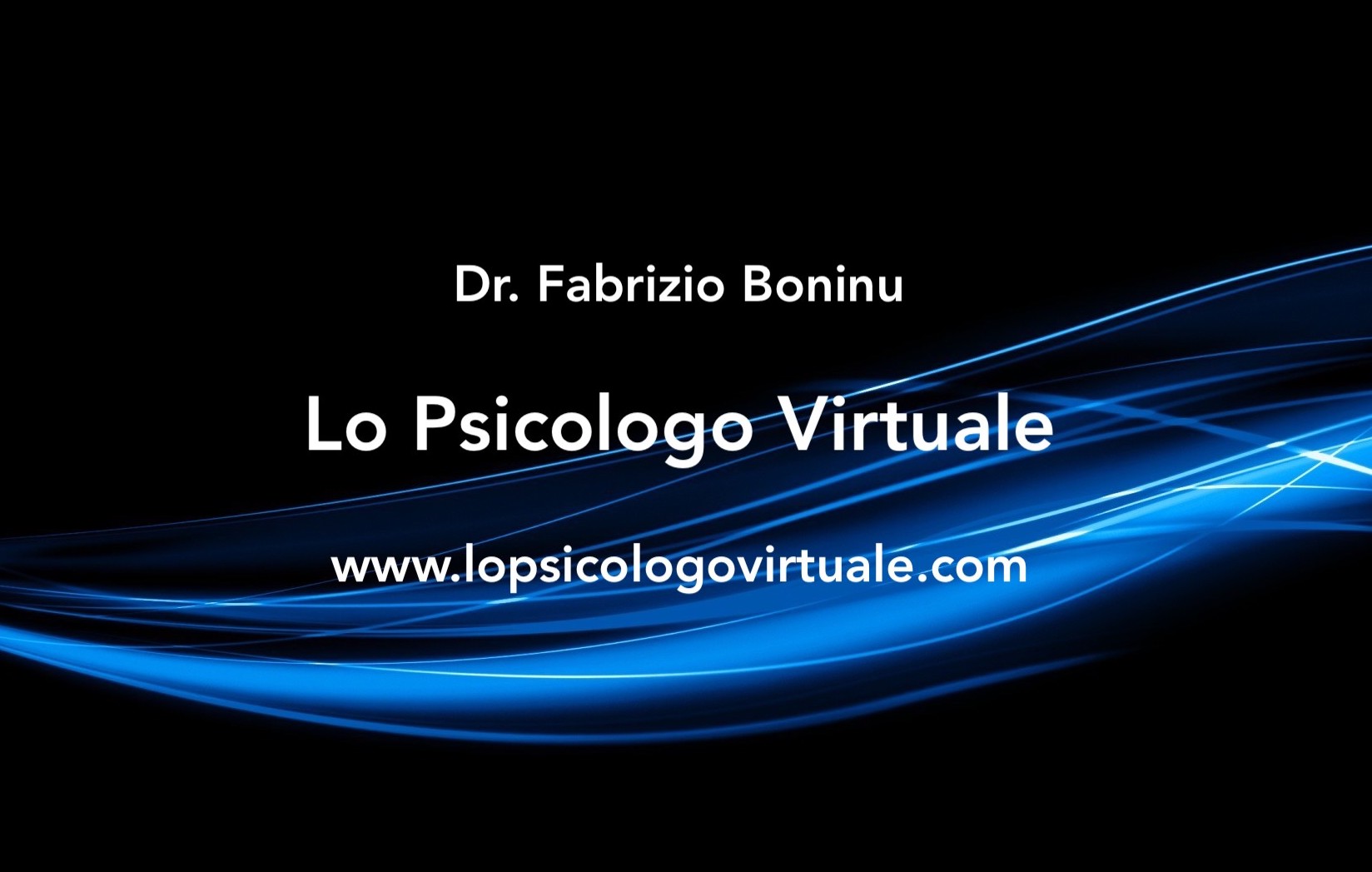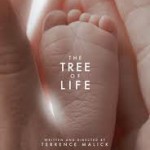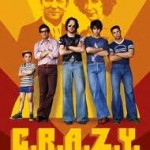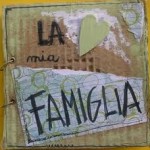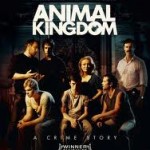Il post di oggi è dedicato ad un fatto di cronaca, che mi ha colpito molto. E’ abbastanza recente, ed è successo in Italia. Un uomo, dell’età di 68 anni, dopo il divorzio da sua moglie ha chiesto il disconoscimento della paternità anche per la figlia, figlia biologica della ex moglie ma non sua, che aveva invece riconosciuto come sua figlia, dandole il cognome, quando si era sposata con la madre. La figlia, (ex figlia?), si è opposta fermamente alla richiesta dell’uomo (ex-padre?) perché, a suo dire lesivo del suo diritto di identità. Il caso ha suscitato, come si poteva immaginare, non poche polemiche rispetto soprattutto al ruolo attuale dei genitori. La prima sezione del TAR del Lazio ha respinto le richieste dell’uomo, sostenendo che la scelta di essere padre, anche se il figlio non è biologicamente suo, non può essere revocata né cancellata per legge.
Il post di oggi è dedicato ad un fatto di cronaca, che mi ha colpito molto. E’ abbastanza recente, ed è successo in Italia. Un uomo, dell’età di 68 anni, dopo il divorzio da sua moglie ha chiesto il disconoscimento della paternità anche per la figlia, figlia biologica della ex moglie ma non sua, che aveva invece riconosciuto come sua figlia, dandole il cognome, quando si era sposata con la madre. La figlia, (ex figlia?), si è opposta fermamente alla richiesta dell’uomo (ex-padre?) perché, a suo dire lesivo del suo diritto di identità. Il caso ha suscitato, come si poteva immaginare, non poche polemiche rispetto soprattutto al ruolo attuale dei genitori. La prima sezione del TAR del Lazio ha respinto le richieste dell’uomo, sostenendo che la scelta di essere padre, anche se il figlio non è biologicamente suo, non può essere revocata né cancellata per legge.
Ora, naturalmente non conosco i dettagli personali di questa famiglia, il dolore o la rabbia che possono avere spinto quest’uomo a pensare di poter fare una così clamorosa marcia indietro rispetto alle scelte che aveva sentito di poter compiere nel momento in cui ha dato il suo cognome alla bimba. Rimane semplicemente lo sgomento di fronte alla leggerezza con cui si pensa al proprio ruolo di genitori. Un padre può davvero pensare di poter disconoscere un figlio dopo che ha passato gran parte della sua vita a stare al suo fianco? E’ pensabile che una scelta di questo tipo non comporti danni psicologici pesanti rispetto all’identità di un figlio che si trova, improvvisamente, a dover ristrutturare l’idea che ha di se stesso e della sua famiglia? Ma soprattutto è pensabile che questa persona sia ancora un genitore? Che padre sarebbe dopo la sentenza che gli impedisce di disconoscere la figlia? Un padre per legge? Il caso è particolarmente delicato anche per la posizione della figlia. La cosa che più salta agli occhi è il concetto stesso di paternità. Paternità biologica e paternità affettiva. Nel caso specifico si parla di paternità affettiva: deve essere considerata meno vincolante di quella biologica? Io non credo.
Credo che una volta che si è assunta una responsabilità di fronte ad un bimbo, sia esso biologico o meno, si deve mantenere la lealtà sulla scelta che si è deciso di compiere. Pensandoci mentre scrivo, credo che, con un figlio adottivo, la lealtà debba essere ancora più ferrea, perché si dovrebbe essere ancora e più consapevoli della scelta che si sta andando a fare, consapevolezza che, spesso, passa in secondo piano per figli biologici per i quali sembra bastare il legame di sangue. In un momento storico in cui le identità sembrano farsi liquide, rarefatte, e i ruoli sempre più invisibili, dove è possibile diventa madri surrogate, o padri adottivi, o si presta il proprio corpo per una gravidanza, sembra passare in secondo piano il significato vero della genitorialità, che prescinde dal legame di sangue e dall’aver biologicamente dato la vita. Quando si sceglie e si decide di diventare genitori, si diventa genitori per sempre. Questo comporta l’avere un patto di lealtà nei confronti dei propri figli. Ovviamente questo non vuol dire l’obbligatorietà dei rapporti tra genitori e figli per tutta la vita. La scelte di ognuno di noi possono portare ad allontanare le persone che ci stanno vicino o ad interrompere i rapporti, compresi quelli più stretti come tra genitori e figli. Ma per quanto i figli possano deludere i genitori o, viceversa, i genitori si trovino nella impossibilità di mantenere un rapporto con loro, o ancora che entrambi, genitori e figli, per varie ragioni non vogliano mantenere i contatti, quello che credo debba essere fatto salvo è che non si può tornare indietro. La lealtà sta in questa impossibilità di tradire il patto fondante del rapporto. Io sono tuo genitore, io sono tuo figlio. E anche se le circostanze della vita possono portare ad un allontanamento, non possono arrivare a mettere in discussione questa verità fondante. Bene ha fatto, a mio parere, il TAR a rigettare la richiesta del padre. L’innovazione nella sentenza è stata dare più peso al legame che si era creato tra padre e figlia piuttosto che accogliere la richiesta del padre.
Il grande merito di questi casi credo sia costringere ognuno di noi a fare i conti e riflettere su aspetti della nostra vita che, perché acquisiti, diamo spesso per scontati. Forse è il caso che ci fermiamo a riflettere su cosa voglia dire essere genitori oggi. Biologici o adottivi credo non faccia alcuna differenza.
Che ne pensate?
A presto…
Tutti i diritti riservati