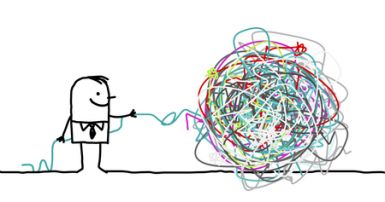La domanda, allora, sorge spontanea: chi proteggono i genitori con la scelta del silenzio? Abbiamo paura di parlare al bambino dei nostri sentimenti, abbiamo timore di mostrare la nostra fragilità. E soprattutto siamo impreparati a discutere – usando termini che i bambini possono comprendere – e a rispondere alla miriade di domande che hanno da porci.
La domanda, allora, sorge spontanea: chi proteggono i genitori con la scelta del silenzio? Abbiamo paura di parlare al bambino dei nostri sentimenti, abbiamo timore di mostrare la nostra fragilità. E soprattutto siamo impreparati a discutere – usando termini che i bambini possono comprendere – e a rispondere alla miriade di domande che hanno da porci.
Sono gli adulti i primi in difficoltà nell’esporre le loro emozioni. I genitori si sentono impreparati a discutere e a confrontarsi su tematiche così vaste. Sono gli adulti a sentirsi in difficoltà nell’immaginare quale tipo di termini possano meglio essere utili per condividere con il bambino l’esperienza della morte. Sono gli adulti che si sentono inadeguati ad avere una conversazione con un bambino su un tema così ostico. Sono gli adulti che sentono la difficoltà di fronteggiare i figli con le loro domande, i dubbi, le paure, le speranze. Quello che gli adulti non si dicono è, in realtà, abbastanza semplice: la morte mette in crisi ognuno di noi. Ci obbliga a riflettere sulla nostra vita e sul suo senso, sul nostro destino, sulle nostre scelte. È questo il confronto che cerchiamo di evitare. Quello con noi stessi, con i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre speranze. Quella serie di domande che un bambino, prima di imparare che di certe cose è sempre meglio non parlare, fa ai propri genitori con il desiderio di condividere queste emozioni.
Come si può interrompere questa catena di silenzi? Una delle possibilità è quella di accogliere senza giudicare le manifestazioni del dolore: la rabbia, lo scoramento, la delusione, il pianto:
Piangere è uno sfogo utile. Spesso ciò che aiuta davvero è piangere con qualcuno per ricevere appoggio e contenimento affettivo. La condivisione affettuosa di un pianto intenso e non trattenuto è una premessa fondamentale. Essa veicola implicitamente un messaggio strutturante, che dovrà successivamente ed utilmente essere esplicitato: ‘Capisco la tua sofferenza, la trovo legittima, la tua sofferenza e anche la mia, insieme possiamo sostenerla. Il fatto che ci vogliamo bene è anche la risorsa con cui possiamo affrontare le paure, le ansie e le separazioni!’
Questo è un punto particolarmente importante. Il pianto potrebbe essere un momento di condivisione, un momento che accomuna le emozioni del bambino e del genitore, un momento nel quale ognuno può sentire accolto l’altro, ognuno coi propri mezzi. Accogliere e non giudicare o distrarre: frasi come ‘smetti di piangere’, ‘tanto piangere non serve a nulla’, ‘pensa ad altro’, torna a giocare’, ‘non ora’, sono frasi dette talvolta senza prestare troppa attenzione e che, invece di aiutare, possono far sentire soli e isolati. Non accolti appunto. E lascia la manifestazione del dolore incompiuta, incompleta e carente.
Tutti i genitori che mi chiedono cosa fare nel caso la morte entri nell’esperienza di vita di un bambino vengono invitati sul terreno della introspezione e della condivisione, convinto come sono che la cosa più utile sia parlare e con-dividere quello che si sta provando. Magari partendo da se stessi, da quello che si prova e da come ci si sente. Indubbiamente temo sia la scelta più ‘difficile’, più ardua da fare perché opposta a tutto quello che ci hanno insegnato, ma credo anche la più responsabile dal momento che permette di dare un senso, di significare un evento nella storia di vita del bimbo che, altrimenti, rimarrebbe inespresso e sospeso.
Per quanto dolorosa sia la perdita, i bambini non hanno bisogno di distrarsi, non hanno bisogno di pensare ad altro, non hanno bisogno di adulti per i quali quello ‘non è il momento adatto’. I bambini hanno un profondo bisogno di verità, hanno un profondo bisogno di adulti che si assumano la responsabilità di raccontare e condividere con loro questa verità, per quanto dolorosa sia anche per gli adulti.
Parlare della morte ai bambini vuoi dire a prepararli a capire la realtà, aiutarli a crescere. Quando muore un nonno, una zia, un genitore, è indispensabile che la verità non venga taciuta o mascherata ai bambini. I bambini sono desiderosi di verità. Se al bambino non è permesso confrontarsi su questo tema cerca di comprenderlo da solo e a volte si crea delle fantasie assurde, il che è molto peggio dell’affrontare la dura realtà della morte. [1]
Verità, non bugie. Avete presente o vi è mai capitato (da genitori o da bambini) che alla morte di una animale domestico lo abbiate (o vi abbiano) semplicemente sostituito l’animale morto con un altro? L’intento è sempre lo stesso: cercare di non (far) vivere l’esperienza dolorosa della morte. Questa apparentemente innocua bugia è la rappresentazione di come affrontiamo la morte: sostituendo l’oggetto amato per non far soffrire. Se l’intento è comprensibile, non altrettanto comprensibili sono le conseguenze di questo gesto: insegniamo (o impariamo) che di alcune cose non si parla, che sono brutte, che sono da dimenticare. Vi invito a fare il contrario: fare una profonda dichiarazione di verità può essere doloroso, ma insegna una grande lezione: non c’è nulla che provo del quale mi debba sentire colpevole di parlare.
Come sempre chi volesse/potesse condividere la sua esperienza può farlo contattandomi per mail (fabrizioboninu@gmail.com) oppure per telefono (3920008369).
Che ne pensate?
A presto…
[1] Bolognini, N. (2010), Come parlare della morte ai bambini, Sie Editore, Pinerolo, pp. 16-17
Tutti i diritti riservati
Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?
Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.
Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.