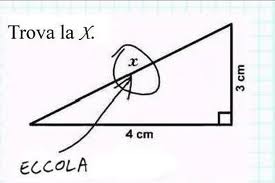Non vi nascondo che ho in mente questa riflessione da parecchio tempo e credo di aver avuto delle difficoltà a metterla per iscritto. Se voleste seguirmi, proverò a spiegarmi meglio. Un ideale punto di partenza potrebbe essere la considerazione su quella che (temo) sia una delle tendenze che noto più spesso in questi tempi: la tuttologia. Questa tendenza affligge tutti coloro i quali, non avendo specifiche competenze in determinati campi (economia, salute, ecc), si vedono invece depositari dello scibile umano e si sentono in dovere di ribadirlo con gli altri, magari anche con persone che stanno faticosamente cercando di costruire una propria competenza in un campo specifico. Talvolta questo avviene con modi non propri mirabili e i tuttologi puntano il dito su quanto ‘gli altri’ non capiscano niente, quanto non comprendano il mondo, come le cose andrebbero fatte in altro modo, o nel peggiore dei casi, che tutto quello che viene fatto/detto/scritto non sia mosso dalle migliori intenzioni. È capitato con alcuni argomenti trattati su questo blog: i post sulle cosiddette teorie riparative o quello sull’omogenitorialità hanno provocato una serie di commenti e di mail non propriamente edificanti. Sono stato accusato di non essere obiettivo, di nascondere delle informazioni, di essere poco trasparente.
Non vi nascondo che ho in mente questa riflessione da parecchio tempo e credo di aver avuto delle difficoltà a metterla per iscritto. Se voleste seguirmi, proverò a spiegarmi meglio. Un ideale punto di partenza potrebbe essere la considerazione su quella che (temo) sia una delle tendenze che noto più spesso in questi tempi: la tuttologia. Questa tendenza affligge tutti coloro i quali, non avendo specifiche competenze in determinati campi (economia, salute, ecc), si vedono invece depositari dello scibile umano e si sentono in dovere di ribadirlo con gli altri, magari anche con persone che stanno faticosamente cercando di costruire una propria competenza in un campo specifico. Talvolta questo avviene con modi non propri mirabili e i tuttologi puntano il dito su quanto ‘gli altri’ non capiscano niente, quanto non comprendano il mondo, come le cose andrebbero fatte in altro modo, o nel peggiore dei casi, che tutto quello che viene fatto/detto/scritto non sia mosso dalle migliori intenzioni. È capitato con alcuni argomenti trattati su questo blog: i post sulle cosiddette teorie riparative o quello sull’omogenitorialità hanno provocato una serie di commenti e di mail non propriamente edificanti. Sono stato accusato di non essere obiettivo, di nascondere delle informazioni, di essere poco trasparente.
Sono d’accordo sul fatto che le posizioni possano essere messe in discussione, d’accordo che si possa criticare tutto (sono il primo a spingere in questa direzione!). Ciò che, invece, non comprendo sono le posizioni di coloro che, non avendo strumenti per parlare del tema specifico, irridono i temi trattati e passino dalle critiche sui temi proposti a contestazioni di tipo personale (sono ‘dalla parte di’, ‘nascondo informazioni’, ‘travio le persone’, ecc). Come ho avuto modo di notare e segnalare più volte, questo avviene senza freni particolarmente nelle interazioni su internet. Da queste premesse sono nate le domande: che cosa origina tutta questa acredine nelle discussioni? Da dove viene questa presunta sicumera? Da dove arriva questa insopportabile saccenza per la quale tutti ostentano di sapere tutto di tutte le cose e irridono gli altri per le proprie posizioni? Dove origina l’incapacità ad accettare le competenze altrui? Se dovessi riassumere queste domande con una sola probabilmente sarebbe: perché molti pretendono di cambiare il mondo partendo dagli altri?
Non volendo specificamente entrare sul tema della competenza e sul conseguente appiattimento nel quale chiunque sembra potersi pronunciare su tutto, l’aspetto che più mi colpisce riguarda il fatto che tutti hanno il desiderio di voler migliorare le cose partendo dagli altri. È l’altro che deve cambiare, è l’altro che deve apportare delle modifiche, è l’altro che deve mutare, ed è sempre l’altro che deve iniziare a farlo. È raro, invece, che una persona inizi partendo da sé, è raro che una persona cominci a pensare di voler cambiare le cose partendo da quello che può fare (o può smettere di fare) per migliorare il mondo o, più semplicemente, una discussione, ed è sempre più raro che una persona metta in discussione le sue scelte, i suoi stili, i suoi pensieri per iniziare a modificare quella che è la società che ci circonda. L’altro è in malafede, l’altro non ha capito nulla, l’altro è prezzolato. L’altro DEVE cambiare il suo atteggiamento/pensiero/azione/emozione. Noi, invece, andiamo bene così.
Qualche tempo fa avremmo potuto etichettare questo automatismo con termini come scissione e proiezione, due tra i meccanismi più primitivi di difesa. Individuata una parte di noi che non ci piace, la scindiamo e la proiettiamo sugli altri potendo, in questo modo, criticare una parte che sentiamo non appartenerci. Questa parte non ci appartiene, appartiene all’altro, eppure ci fa arrabbiare molto. Da dove deriva tutta questa rabbia? Una possibile spiegazione potrebbe essere che questa parte ‘rifiutata’ in realtà sia a noi molto vicina e che questa scissione, questo non riconoscimento per una parte così importante di noi, per quanto non ci piaccia, provoca una profonda rabbia. A questa spiegazione possiamo aggiungerne una più generale e cioè che le persone, sempre più consapevoli della complessità del mondo che ci circonda, nel quale con sempre più fatica si distingue tra le diverse posizioni, avvertendo la minore influenza del proprio peso e il conseguente senso di impotenza, reagiscano così, con rabbia. E questa rabbia spesso si sfoga su chi si espone, su chi cerca di fare.
Da qui voglio partire. Sovvertire questo meccanismo in me. Non chiederò a voi di cambiare per migliorare il mondo nel quale viviamo: lo chiederò a me stesso. Conoscete i buoni propositi per l’anno nuovo? Ecco, anche se inizio anno è oramai lontano, quest’anno come buon proposito voglio iniziare da me. Voglio essere sicuro di fare del mio meglio nel mio campo per cercare di migliorare, nel mio piccolissimo, la nostra società. Non voglio dare suggerimenti, non voglio dare consigli, non mi intendo delle cose che fanno gli altri, non sono in grado di sostituirmi a chiunque e non ho il sapere su tutto. Ho scelto una professione, una professione delicata e complessa, ho deciso di investire in questo campo, ho deciso di formarmi in questo campo. E questo non mi da la possibilità di essere esperto in altri campi ed è per questo che mi fido e affido alle competenze degli altri. Come disse qualcuno tanti anni fa, l’unica cosa che so è di non sapere. Per questo non mi voglio arrogare il diritto di contestare, criticare o denigrare quelle che sono le competenze degli altri. Io parto da me, e posso solo garantire il mio impegno e la mia passione. Anche i miei errori. Quello che non voglio fare è migliorare il mondo in cui viviamo partendo da voi. Credo sarà il cambiamento, l’impegno, la passione che ognuno di noi può esercitare su se stesso a cambiare le cose. E non la critica aprioristica delle posizioni degli altri. Partirò da me, da quello che faccio, da come mi comporto, da come reagisco, da come mi arrabbio.
Cercherò, per quanto sia più facile e più semplice, di non limitarmi ad incolpare gli altri, di ritenere tutti gli altri, eccetto me stesso, responsabile di quello che ci circonda. E credo non sarà facile, in questa continua rincorsa alla ‘colpa degli altri’ e alla incapacità di osservare se stessi. Mi sono stancato di partire dall’altro, mi sono stancato di attribuire all’altro. Provo a rivolgere lo sguardo su di me, cercando di vedere cosa faccio, dove posso migliorare, dove ancora sbaglio e perché lo faccia.
Parto da me e su me cerco di stare, prendendomi la pesante responsabilità di quello che creo e di come lo creo. Cercando di non cadere nella facile tentazione di accusare gli altri come soli responsabili di quello che mi/ci succede.
A presto…
Tutti i diritti riservati