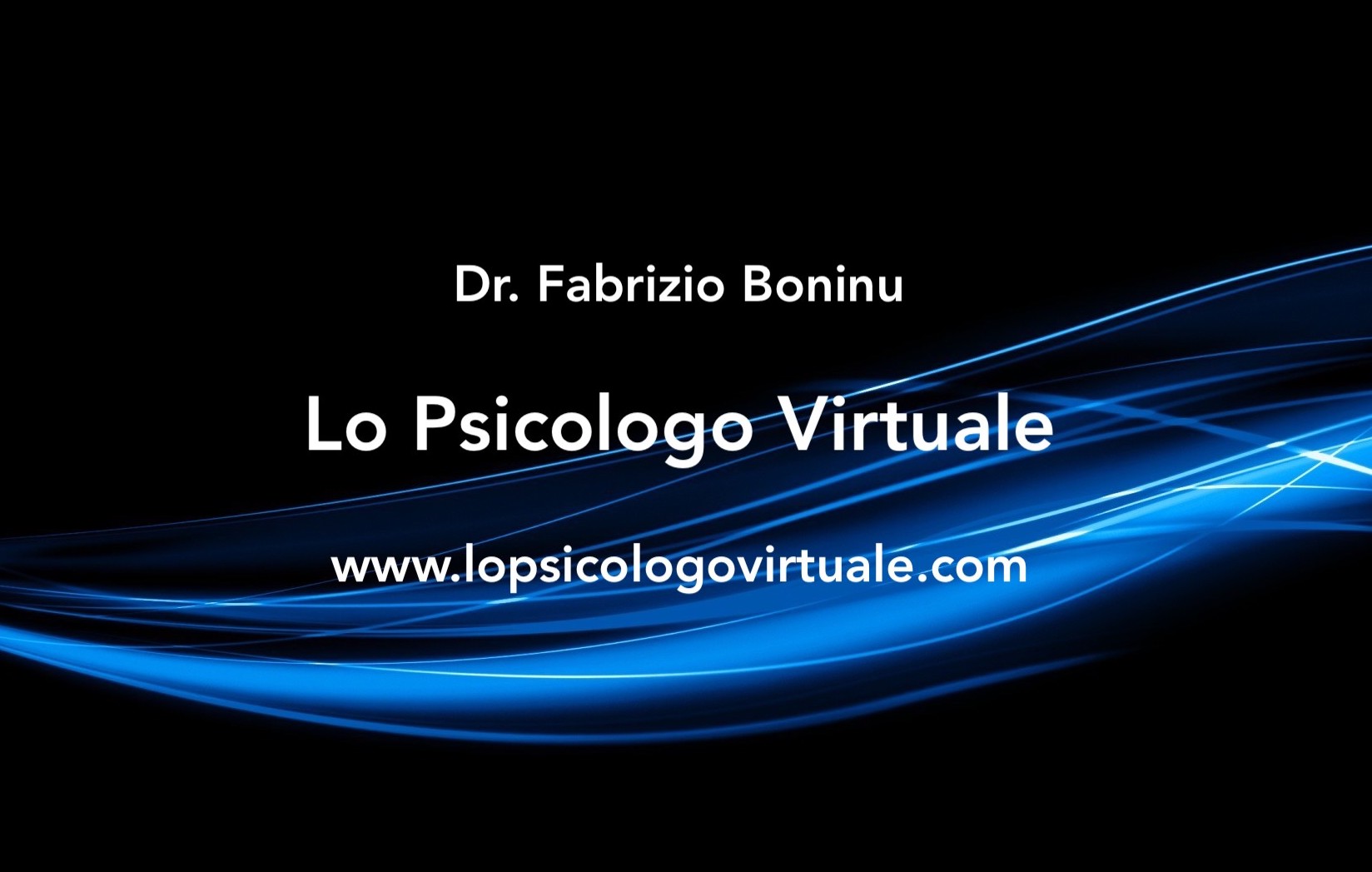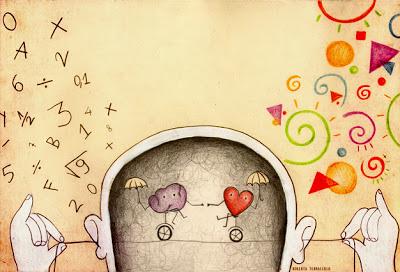La consapevolezza, funzione psichica capace di generare benessere e di sollecitare il cambiamento, può attivarsi se prevale un atteggiamento mentale di accettazione e, contestualmente, di rinuncia al controllo onnipotente della realtà. Fintanto che un soggetto si tormenta con proposizioni del tipo: ‘Avrei potuto, avrei dovuto…’, ‘Avrebbe potuto, avrebbe dovuto…’, finisce per disperdere energie preziose in vissuti logoranti di colpa, di depressione o piuttosto di rabbia, energie sicuramente sottratte a quell’impegno di consapevolezza, massimamente utile per affrontare i problemi e le difficoltà dell’esistenza. La consapevolezza delle emozioni può iniziare quando cessa il combattimento finalizzato al tentativo di eliminare vuoi le emozioni sgradite, vuoi la realtà che le ha generate ed inizia la processazione dei dati emotivi, così come possono essere rilevati nella loro specificità e nella loro autenticità. Non c’è consapevolezza se non c’è rinuncia al dominio, cioè se non lasciamo andare la pretesa di controllare tutto.
Il nostro atteggiamento è spesso, invece, improntato al controllo, alla valutazione, al giudizio che ci portano lontani dalla consapevolezza e ci avvicinano a reazioni come l’impotenza, la rabbia o la tristezza. La frustrazione è doppia perché da un lato non riusciamo nell’intento di controllare quello che proviamo, dall’altro, non essendoci potuti soffermare a capire cosa fosse quello che stavamo vivendo, aumenta il nostro senso di estraneità per noi stessi, di non conoscerci a fondo di non sapere neanche noi chi siamo. Come può questo sentire farci stare bene? Come può condurci ad una conoscenza migliore di noi stessi? Qual è il modo attraverso il quale superare questo cortocircuito tra ragione ed emozioni, questa sorta di impasse interno a noi stessi? Il primo passaggio riguarda l’accettazione di quello che proviamo, cercando di far stare fuori il giudizio, metro razionale che tentiamo di applicare alla realtà emotiva:
Per elaborare le emozioni occorre accettarle innanzitutto così come si manifestano nella nostra mente prima di cercare di elaborarle. Nel momento in cui la consapevolezza accetta le emozioni, anche le più stressanti, le circoscrive ed in qualche misura la fa evolvere. Nominare la confusione per esempio può essere il primo organizzatore mentale e linguistico della confusione stessa, l’avvio di un percorso per fare emergere un qualche elemento di chiarezza dal caos. Nel momento in cui non pretendo di dominare o manipolare queste emozioni, bensì tento di riconoscerle e di pensarle, per ciò stesso si rinforza un area della mente che riduce il rischio del sequestro emozionale: prendo atto che in me c’è rabbia o c’è tristezza, ma non c’è solo rabbia o tristezza, perché si attiva una funzione di consapevolezza che si rende conto della rabbia e della tristezza; mi accorgo che in me c’è ansia, ma non dilaga, perché c’è un’isola della mia mente dove si attiva la capacità di dare un nome all’ansia. [1]
Uno dei punti nodali sta proprio nella capacità di riconoscere e dare un nome a quello che proviamo perché questa capacità ci rende l’idea che nel momento in cui ci sia un sentimento avvertito come negativo, esista anche una sorta di contraltare dentro di noi che ci consente di capire come non siamo del tutto preda o in balia solamente di quella emozione. Se ci limitiamo a giudicarci (non sono adatto, non sono in grado di, non è normale provare questo,…) focalizziamo la nostra attenzione e la nostra consapevolezza solamente su come ci stia facendo stare male quello che proviamo, su come questo sentirci ci faccia stare male, ma non su cosa stiamo effettivamente provando. Se riuscissimo, invece, nel momento in cui proviamo un’emozione a riconoscerla, sentiremo che dentro di noi esiste un’area che riesce a non farsi travolgere dall’emozione stessa, un’area che la identifica e costituisce il primo passo perché quell’emozione sia riconosciuta e possa entrare a far parte della nostra stessa realtà psichica.
Non è sicuramente un processo facile, vanno scardinati una serie di automatismi censori e neganti che da sempre tentano di mettere a tacere la nostra realtà emotiva. Non è facile, dicevo, ma è un primo passo per portare luce su parti di noi stessi trascurate, nascoste e condannate, il mancato riconoscimento delle quali è spesso responsabile del nostro stare male.
A presto…
[1] Foti, C. (2012), La mente abbraccia il cuore, Edizioni Gruppo Abele, Torino, pp. 52-54