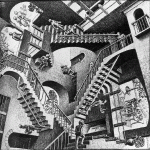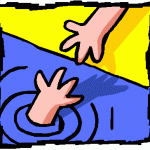Questa riflessione sul suicidio parte da una frase letta in un libro che mi ha portato a rivedere le mie (credo condivise!) convinzioni circa il suicidio. Il suicidio è l’atto estremo di una persona che rinuncia a vivere la sua vita. O se vogliamo che decide di vivere la vita ( e terminarla) esattamente come ritiene più consono per lui.
Questa riflessione sul suicidio parte da una frase letta in un libro che mi ha portato a rivedere le mie (credo condivise!) convinzioni circa il suicidio. Il suicidio è l’atto estremo di una persona che rinuncia a vivere la sua vita. O se vogliamo che decide di vivere la vita ( e terminarla) esattamente come ritiene più consono per lui.
All’interno della nostra società, l’atto del suicidio è stato da sempre ostracizzato, tanto che il suo rifiuto è stato anche codificato all’interno di norme religiose applicate per secoli. I suicidi, per esempio, nelle società occidentali, non potevano essere sepolti al’interno dei cimiteri cristiani. Colui il quale osava portare via a Dio il potere di terminare la propria vita, prerogativa, appunto, divina, non poteva godere dell’eterno riposo laddove ne godevano gli altri. A parte che ci sarebbe da discutere sul perchè, allora, Dio ci abbia lasciato in mano un simile potere (ma sarebbe un discorso che ci porterebbe troppo lontano dall’argomento!), anche solo questo esempio è indicativo di come venisse e venga percepito il suicidio nella società. La carica simbolica altamente eversiva che il suicidio comporta, porta ad una sua netta condanna quali che fossero le cause che spingevano la persona a compierlo.
E fin qui, credo, nulla quaestio. Il dubbio sorge su quelle convinzioni cui vi accennavo prima. Ho sempre pensato che il suicidio fosse un fatto privato, un fatto legato alla vita dell’individuo che lo compie. A rigor di termini, il suicidio non è un fatto privato, come non lo è qualsiasi morte che lasci addolorate le persone che, con il defunto, avevano dei rapporti. In questo, appunto, non è un fatto privato, come non lo è, forse, nessuna morte. Ma se questo valore sociale appartenesse anche alla scelta del suicidio stesso? Mi spiego megio. Sono sempre più convinto che l’uomo sia frutto delle relazioni che lo circondano. Continuo a ripetervi che tra le mie convinzioni più profonde si trova il fatto che qualsiasi cosa facciamo è di per se stessa relazionale, dal momento che la pensiamo/facciamo/condividiamo con altri. Solo che, non so per quale automatismo, in queste considerazioni continuo a non comprendere alcune cose. Anche il suicidio era considerato una sorta di eccezione. A farmi riflettere su questa mia convinzione è stata la lettura di uno scambio di battute tra Carl Whitaker e William Bumberry. Ve lo riporto:
Domanda: Bé, mi pare un’idea un pò strana. Intendi dire che se la madre ha tendenze suicide è perché qualcuno la vuole morta?
Carl: Certo, proprio così! Il suicidio è come ogni altra cosa: tutte queste faccende sono interpersonali. Io credo veramente nei sistemi! Non posso credere che gli individui agiscano come unità, penso invece che operino soltanto come parti di unità più grandi. (Carl Whitaker, Danzando con la famiglia, Astrolabio, Pag 166)
Ecco il grande capovolgimento di prospettiva. Se tutto è relazionale per quale motivo il suicidio dovrebbe essere un atto personale? Ovviamente sto parlando di relazioni, non di colpe. Questo vuol dire che non credo che una persona spinga un’altra al suicidio, quanto che il suicidio sia una risposta ben precisa che dovremmo valutare allargando il focus dal singolo alle relazioni significative che su quella scelta possono avere influito. Insomma, c’è la possibilità di valutare e, forse, comprendere un gesto così netto solo immaginando di coinvolgere un livello più ampio di relazioni. Credo di intuire che potrebbe essere un argomento dibattuto, ma credo che poterne parlare, poterci riflettere sia meglio di dare come acquisite alcune nostre prospettive alle quali sembriamo tanto affezionati. Trappola nel quale io stesso ero caduto.
Che ne pensate?
A presto…
Tutti i diritti riservati