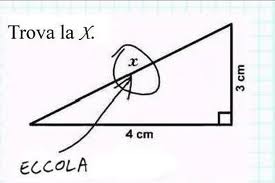– Attaccare continuamente l’autoconsapevolezza del reprobo, tramite l’istigazione alla confusione, all’incertezza e all’insicurezza, la promozione di ogni dinamica di autosqualifica e l’imposizione di immagini degradate precostituite. Si lede in questo modo nelle persone omosessuali un diritto umano cruciale: quello di potersi valorizzare nelle forme affettive amorose che più corrispondono alla propria autenticità. Si impedisce al diverso di esprimersi alla pari con gli altri: è la strada maestra per raggiungere anche tutti gli altri obiettivi. In questo modo si impedisce al deviante – e ai suoi familiari – ogni alternativa esistenziale, sociale, etica e prima ancora psicologica. Egli deve vedere davanti a sé solo la distruzione di ogni prospettiva e del futuro, una completa mancanza di speranza e di senso, perdendo ogni sfiducia e aspettativa di bene.
– Impedire in tutti modi che il soggetto elabori una visione alternativa positiva di sé e della propria affettività: ogni tecnica deve essere impiegata per rendere il soggetto incapace di operare un distacco dalla visione negativa in cui è cresciuto. Egli deve trovarsi così senza punti di riferimento, bandito e disprezzato dalla comunità di appartenenza, squalificato eticamente e psicologicamente e dunque leso nel proprio Sé. Deve arrivare ad autoaccusarsi di negare i valori di correttezza, di seguire le leggi di Dio, della natura, dell’ordine fecondo del mondo.
– Sottoporre le persone omosessuali – e la loro famiglie – a predizioni negative catastrofiche, imputando loro un destino maligno e infelice; e lanciare profezie di sventura perché fatalmente sia avverino. D’altronde, è facile fare profezie negative sul triste destino degli oppressi, perché distruggere le possibilità è assai più facile che costruirne. Ecco perché in questi testi c’è un’insistenza drammatica sulla disperazione e la negatività di ogni cosa che riguarda il gay, così come una massificazione deterministica. Perché se venisse fuori che tante sono le possibilità e le forme di vita, allora vorrebbe dire che differenti sono i destini che le persone omosessuali possono avere. E, dunque, è possibile sottrarsi al percorso nefasto che si vorrebbe loro imporre come destino. Addirittura, è possibile vivere serenamente. Che fine farebbero, allora, le minacce alle profezie apocalittiche così facilmente sollecitate? [1]
Divisione, contrapposizione, espulsione, istigazione, patologizzazione sono solo alcune delle caratteristiche di questo tipo di teorie che basano il loro successo sulla divisione tra una (presunta) normalità da perseguire e un’anormalità da colpire e ostracizzare. Questo bisogno di etichettamento porta a non considerare la storia dell’individuo, le sofferenze che, spesso per la colpevole repressione sociale che ancora circonda le scelte sessuali individuali, caratterizzano la sua vita e anzi, approfittando di questa debolezza e di questo bisogno di (presunta) normalità, cerca di instillare il bisogno di accettazione nel paziente insistendo su quanto potrebbe essere migliore una scelta sessuale che sia socialmente approvata e non repressa ed ostacolata e come questo potrebbe significare minore sofferenza per il soggetto stesso. Quest’ultimo, affidandosi e fidandosi del suo terapeuta, ritiene che una scelta di questo tipo possa essere preferibile e possa evitare alcune sofferenze sebbene sia una scelta che si accompagna alla repressione e al rinnegare i propri istinti più naturali, più ‘normali’ proprio perché innati.
É contro questo tipo di deriva patologizzante che ci siamo impegnati, mettendoci anche la faccia, per ribadire la scorrettezza di questo tipo di pratiche. Pressioni di questo tipo sono profondamente scorrette qualunque sia il tema, dal momento che il terapeuta non ha il compito di dire al suo paziente cosa debba fare/essere, quanto di cercare di capire con lui quali scelte siano più adatte nella sua vita. E, non dimentichiamolo, costituisce una violazione profonda del Codice Deontologico degli Psicologi il quale, all’articolo 3, sancisce come lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
Insomma ancora una volta il rispetto della persona che ci si siede davanti dovrebbe venire prima di tutte le nostre considerazioni personali, morali o religiose che siano. Questa attenzione è premessa per me indispensabile per svolgere con correttezza e attenzione il delicato lavoro che abbiamo scelto di portare avanti.
Come sempre chi volesse/potesse condividere la sua esperienza può farlo contattandomi per mail (fabrizioboninu@gmail.com) oppure commentando il post.
A presto…
[1] Rigliano, P., Ciliberto, J., Ferrari, F. (2012), Curare i gay?, Raffaello Cortina Editore, Milano, pp. 170-172
Tutti i diritti riservati
Vuoi ricevere tutti i post de LO PSICOLOGO VIRTUALE?
Iscriviti GRATUITAMENTE alla newsletter e riceverai ogni nuova pubblicazione direttamente sulla tua mail.
Per iscriverti, clicca su NEWSLETTER e segui le semplici istruzioni.