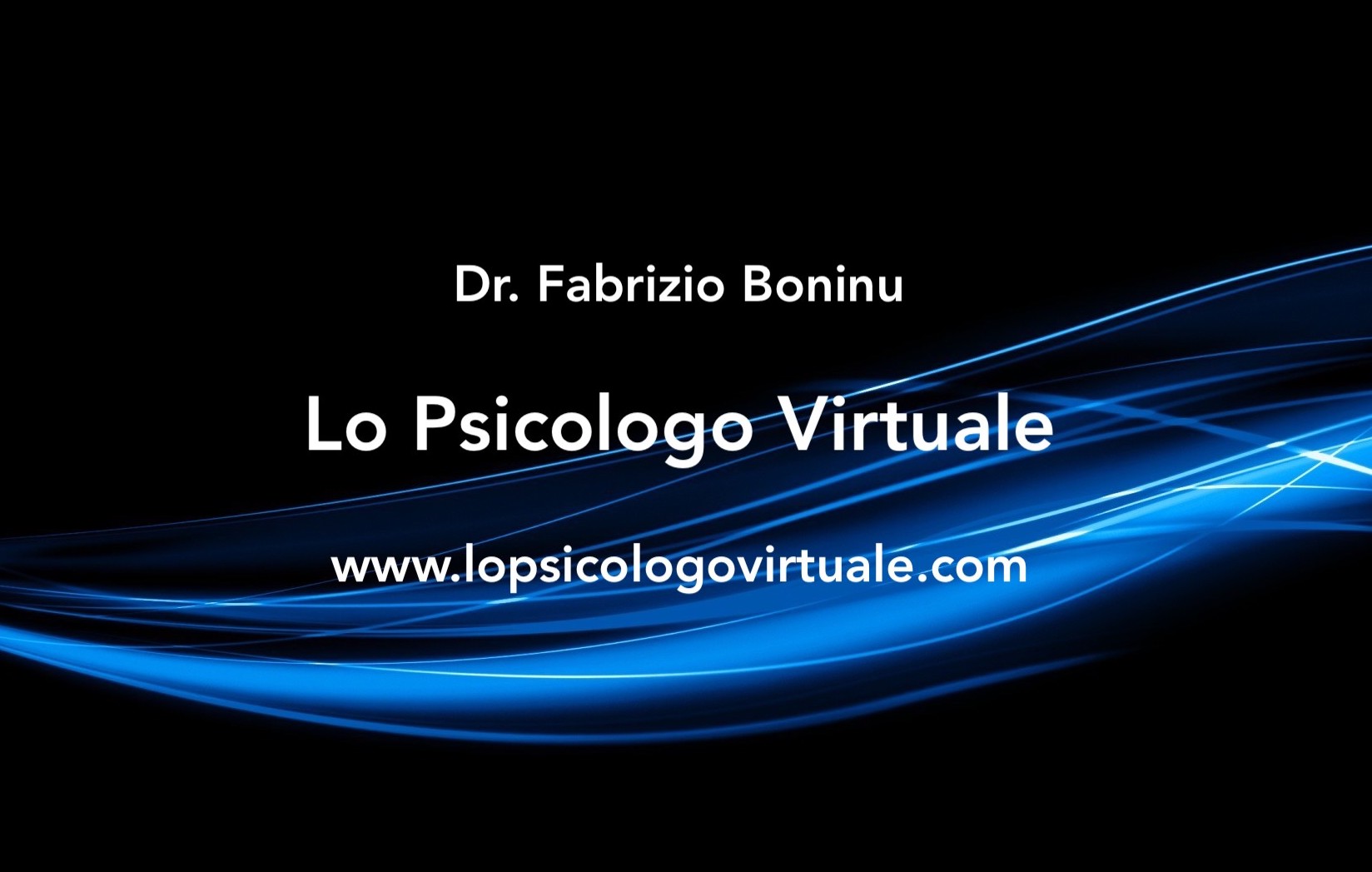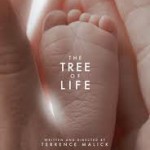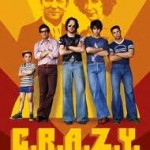Molti studi in materia, per quanto lacunosi e problematici dato il silenzio che avvolge le persone che hanno subito questo tipo di esperienza, hanno evidenziato come molte delle persone che partecipavano a queste esperienze provenissero dalla classe media o da contesti sociali non particolarmente problematici sia dal punto di vista sociale che monetario. Il silenzio che avvolge questo tipo di vicende, a meno che non accadano fatti particolarmente eclatanti, porta anche a sottostimare il fenomeno. È stato ipotizzato che esistano in Italia circa cinquecento sette di tipo ‘religioso’ che coinvolgono circa l’1% della popolazione nazionale (600.000 persone circa) (fonte: Maurizio Alessandrini, presidente dell’Associazione nazionale familiari delle vittime delle sette (Favis))
Molti studi in materia, per quanto lacunosi e problematici dato il silenzio che avvolge le persone che hanno subito questo tipo di esperienza, hanno evidenziato come molte delle persone che partecipavano a queste esperienze provenissero dalla classe media o da contesti sociali non particolarmente problematici sia dal punto di vista sociale che monetario. Il silenzio che avvolge questo tipo di vicende, a meno che non accadano fatti particolarmente eclatanti, porta anche a sottostimare il fenomeno. È stato ipotizzato che esistano in Italia circa cinquecento sette di tipo ‘religioso’ che coinvolgono circa l’1% della popolazione nazionale (600.000 persone circa) (fonte: Maurizio Alessandrini, presidente dell’Associazione nazionale familiari delle vittime delle sette (Favis))
Spesso questi gruppi non costituiscono un problema per l’ordine sociale, anche perché non hanno nessun interesse ad attirare su di loro l’attenzione, specie dei media, ma in alcuni casi sono state legate a fatti di cronaca particolarmente efferati. Waco, I Cancelli del Cielo, l’Ordine Del Tempio Solare sono solo alcuni dei nomi di sette associate a veri e propri massacri.
Tornando alle caratteristiche individuali che possono spingere ad entrare in contatto con questo mondo due fattori possono essere importanti nello spingere ad entrare in questo tipo di organizzazioni. Da una parte veri e propri fattori depressivi che, non permettendo di riconoscersi come persone competenti o autonome può, ovviamente in casi estremi, portare a ricercare gruppi nei quali sentirsi accettati. Il secondo fattore credo possa essere, appunto, il senso di appartenenza o meno ad un gruppo. Se una persona ha buoni rapporti sociali, li giudica soddisfacenti e consoni alla sua vita, probabilmente non avrà bisogno di sentirsi accettato e difficilmente cercherà un tipo di gruppalità che sull’adesione ad alcuni valori, come abbiamo visto, ha costruito il suo collante. Questo senso di straniamento potrebbe essere caratteristico di fasi di passaggio della vita ‘normale’ delle persone e potrebbe causare delle ripercussioni sulla percezione del soggetto rispetto a se stesso.
Con questo non voglio dire che qualunque fase di passaggio coincida con il pericolo di finire in vicende di questo tipo. Credo sia necessario, però, prestare attenzione a questo fenomeno. Soprattutto credo sia necessario cercare di capire e di comprendere il perché una persona si rivolga a quella che crede una possibile soluzione. Al di là di tutte le generalizzazioni che necessariamente si devono usare per descrivere fenomeni così ampi, dobbiamo ricordare che dietro ad ogni singola scelta, anche quelle che sembrano più sconvenienti, vi è un bisogno, spesso un falso bisogno, che deve essere soddisfatto. Inviterei chi ha o chi ha avuto questo tipo di esperienze a rivolgersi all’Associazione nazionale familiari delle vittime delle sette oppure alle autorità competenti. Naturalmente sarebbe necessario anche un lavoro di supporto psicologico che consenta alla persona che è stato direttamente interessata dall’esperienza di elaborare e comprendere le ragioni profonde della sua scelta.
Avete esperienze in merito? Se voleste condividerle, potete contattarmi via mail (fabrizioboninu@gmail.com) oppure via telefono (392 0008369).
Vi lascio con i link che mi hanno consentito di elaborare questo post:
Associazione nazionale familiari delle vittime delle sette;
Se vuoi leggere i primi articoli clicca sul link: LE SETTE (1), LE SETTE (2)
A presto…
Tutti i diritti riservati