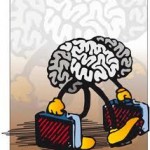Una delle domande più frequenti che mi vengono fatte è sicuramente quella del perché non posso prendere in terapia amici o persone che già conosco. ‘Ma scusa, ci conosciamo già, avrei meno difficoltà a raccontarti alcune cose della mia vita, perché non posso venire da te?’ In effetti, visto dall’esterno, il fatto che uno psicologo non possa fare terapia ad un suo conoscente sembra un controsenso. Nell’accezione comune, il fatto che ci si conosca aiuta ad aprirsi e rende più facile andare da un professionista.
Una delle domande più frequenti che mi vengono fatte è sicuramente quella del perché non posso prendere in terapia amici o persone che già conosco. ‘Ma scusa, ci conosciamo già, avrei meno difficoltà a raccontarti alcune cose della mia vita, perché non posso venire da te?’ In effetti, visto dall’esterno, il fatto che uno psicologo non possa fare terapia ad un suo conoscente sembra un controsenso. Nell’accezione comune, il fatto che ci si conosca aiuta ad aprirsi e rende più facile andare da un professionista.
Perché allora è categoricamente meglio non farlo? Quello che dall’esterno appare come un punto di forza, visto dall’interno della relazione terapeutica appare invece come un’enorme debolezza. Parte dell’effetto della terapia è dato dal fatto che il terapeuta sia estraneo alla vita della persona che prende in carico. Questa estraneità fa sì che il paziente possa fidarsi, dato che il terapeuta non è orientato verso nessuno delle persone coinvolte nel racconto della vita del paziente, è estraneo alle sue dinamiche familiari ed è, in una parola, equidistante da tutti. Poniamo, invece, il caso contrario: il terapeuta e il paziente sono amici/conoscenti. In questo caso è probabile che il primo conosca persone che fanno parte della vita del suo paziente e il paziente, a sua volta, di persone che fanno parte della vita del terapeuta o, ancora più probabile nel caso le due persone fossero amiche strette, condividano le persone che conoscono. Questo è problematico perché potrebbe rendere meno liberi entrambi di parlare di queste persone: il paziente potrebbe non voler parlare di cose che coinvolgano anche il terapeuta mentre il terapeuta potrebbe essere meno libero nel poter fare restituzioni che coinvolgano persone conosciute da entrambi. Insomma non ci sarebbe una libertà di movimento che è invece indispensabile nella relazione terapeutica.
Altra difficoltà è che il terapeuta e l’ipotetico paziente/amico conoscendosi prima della terapia siano in un rapporto paritario nella relazione. Una dei capisaldi della terapia, che la distingue da un rapporto tra amici, è che una persona si espone molto nella relazione l’altra meno. Se ci fosse un rapporto amicale tra terapeuta e paziente, questa premessa non esisterebbe perché anche il paziente saprebbe tutto della vita del suo terapeuta. Entrambi sarebbero esposti allo stesso modo e questo inficerebbe non solo la costruzione di una relazione terapeutica (dal momento che già esiste una relazione amicale) ma di fatto impedisce l’uso che il terapeuta può fare delle proprie esperienze di vita in terapia. Come può il terapeuta utilizzare qualche dettaglio della sua esperienza dal momento che l’amico probabilmente conoscerebbe già l’episodio raccontato?
Va inoltre ricordato che essendo conoscenti potrebbero esserci delle risonanze nelle dinamiche personali che potrebbero entrare in gioco nel rapporto terapeutico stesso. Mi spiego meglio: se una persona conosce l’altra è già presente nella loro relazione una serie di elementi (pregiudizi, idee, impressioni) su quella persona. Anche in questo caso queste premesse possono invalidare la costruzione del rapporto tra terapeuta e paziente. In una relazione terapeutica ‘ideale’, invece, la costruzione del rapporto avviene nella terapia stessa, e non dovrebbero esserci elementi conoscitivi pregressi che possano entrare in gioco.
Per questi motivi è sempre bene evitare di prendere un amico o un conoscente in terapia e, piuttosto, inviarlo ad un collega che goda della nostra fiducia. Non è un atto di incomprensione e il motivo non è non volersi prendere cura del proprio conoscente. La ragione è, piuttosto, aver chiara una visione dei confini della propria professione, non cercare di sovrapporla al ruolo amicale e capire quando possiamo non essere la persona più adatta per fare un lavoro con un nostro amico. Questo non impedirà al nostro amico di annoverare tra le sue conoscenze uno psicologo conscio dei suoi limiti potendo, in più, avere anche il suo ascolto (come amico!) qualora volesse condividere l’esperienza della terapia.
Che ne pensate?
P.s.: Approfitto di questo post per salutarvi per qualche settimana. La serie di nuovi progetti sui quali sto lavorando, sommati a quelli portati avanti in questo proficuo 2014, entusiasmanti ed impegnativi allo stesso tempo, richiedono che mi ricarichi le batterie e sono consapevole del fatto che solo una persona che si prende cura di se stessa può efficacemente prendersi cura degli altri.
Vi lascio comunque in compagnia di oltre 200 articoli tra i quali potete trovare la lettura che vi interessa. Vi saluto, vi auguro un Buon Natale ed un felice anno nuovo. Ci rivediamo a Gennaio..
…a presto…
Tutti i diritti riservati